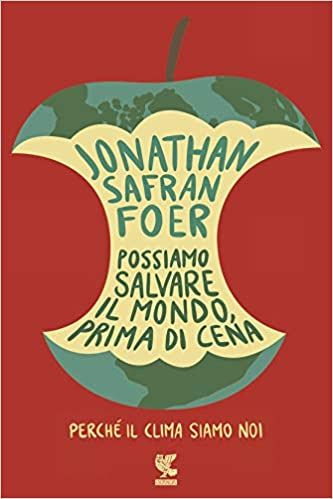#14 La terra brucia, embè?
L'ambiente raccontato male; poca carne per Safran Foer; la sesta estinzione di Kolbert; io nelle acque di Ischia; i ragazzi dell'Oregon che fan causa per il pianeta; dal fracking al solare; Watchmen
ARTICOLI. VIDEO. PODCAST. LIBRI. LIVE. BIO.Prologo
La prima volta che ho capito bene quale fosse il problema giornalistico del riscaldamento climatico è stato durante una chiacchierata a Lima, in Perù, con Lizzy Cantù, all’epoca vicedirettrice di Etiqueta Negra (leggete qui la cronaca di quell’incontro). Il problema è che spesso è una storia lenta (lo scioglimento della calotta artica non avviene da un giorno all’altro) e molto spesso è raccontata male, in maniere noiosa e moraleggiante. Di certo non era un problema loro che avevano fatto addirittura uno spin off del mensile sui temi ambientali, Etiqueta Verde, che aveva i consueti pezzi magnifici titolati tipo Un cane senza pelo nella terra degli uomini barbuti. Se vogliamo che il messaggio passi, bisogna raccontarlo meglio.
OGNI COSA È CLIMATIZZATA
Uno che l’ha capito è Jonathan Safran Foer. Nell’estate 2019 mi avevano chiesto di andare a intervistarlo a New York in occasione dell’uscita del suo nuovo libro. Che non era un romanzo ma un saggio su come si poteva rallentare il riscaldamento del pianeta mangiando meno carne. Non ero entusiasta. Il romanzo che l’aveva reso celebre, Ogni cosa è illuminata, mi era sembrato un giochino ripetitivo. E sebbene rispettassi le obiezioni morali al consumo della carne che aveva raccontato nel saggio precedente continuavano ad appassionarmi molto di più (sì, lo so che un pensiero un po’ rozzo e Peter Singer non approverebbe) le sofferenze degli esseri umani, di cui pure c’era abbondanza. E invece mi ero dovuto ricredere. La conversazione, che doveva durare un’ora, si era rivelata così interessante (e non mutualmente spiacevole) che di fatto era raddoppiata. All’opera, in ogni frase, veniva fuori il precipitato di un argomento intellettualmente onestissimo, cesellato nel tempo, potente. Un estratto del pezzo (qui l’integrale per abbonati):
Una parte di questo drammatico scollamento ha anche a che fare con la difficoltà che giornali e letteratura hanno nel raccontare il fenomeno: perché?
«Perché non è una buona storia, è astratta. Procede in maniera incrementale: che suspense c’è nella calotta artica che si scioglie? È letteralmente la cosa più noiosa del mondo. E tende alla ripetitività: quante volte, ormai, abbiamo sentito ripetere “le peggiori inondazioni degli ultimi cento anni?”.Ogni anno. E senza una buona storia non convinci nessuno. Era vero 5.000 anni fa e resta vero oggi. Bisogna reinventare il modo in cui lo raccontiamo. Per alcuni saranno manifesti, film, racconti basati sui fatti o sulle emozioni: qualsiasi cosa, basta che funzioni. Dovremo tentare gli uni e gli altri, perché il tempo stringe e o questo o quello non possiamo più permettercelo».
A proposito dell’importanza di un buon storytelling, il libro svela la verità sulla prima donna che si oppose alla segregazione in America…
«Sì, e non è quella della storiografia ufficiale. La prima arrestata a Montgomery per essersi rifiutata di alzarsi e lasciare posto a un bianco sul bus non fu la celeberrima Rosa Parks ma la sconosciuta Claudette Colvin. Ma aveva quindici anni, era incinta di un uomo sposato, molto più vecchio di lei, e veniva da una famiglia povera. Niente a che vedere con la quarantaduenne Parks, sposata, di famiglia rispettabile, che provocò di nuovo l’incidente nove mesi dopo. Quella di Claudette era una storia non abbastanza buona per passare alla Storia. Oppure mi viene in mente Jackson Pollock quando lavorava su tele lunghe 20 metri e poi ne ritagliava una parte soltanto: quella era l’opera d’arte, non il resto. È la selezione giusta che fa la differenza. Era una manipolazione, ma ogni scelta è una manipolazione».
CRONACHE DALLA SESTA ESTINZIONE
Più ancora di Foer la regina del racconto del pianeta a picco è Elizabeth Kolbert del New Yorker. L’ho conosciuta a Roma, durante un anno che ha passato all’American Academy dove l’ho intervistata nel gennaio 2016. Il suo libro La sesta estinzione è una collezione di storie una più appassionante dell’altra. Ha appena pubblicato un nuovo libro, Under the White Sky, che immagino altrettanto bello. Un estratto della nostra conversazione (qui l’integrale):
Ma torniamo al titolo. Le specie si estinguono in due modi. Uno naturale, lentissimo (tra i mammiferi un'approssimazione parla di una scomparsa ogni 700 anni). Uno di massa, come il meteorite di dieci chilometri di diametro che 66 milioni di anni fa impattò sulla Terra cancellando dalla sua faccia, oltre ai dinosauri, circa i tre quarti delle specie allora viventi. La prova di quella collisione, racconta Kolbert, si è trovata per la prima volta a Gubbio, in una striscia di argilla, la scaglia rossa, che contiene livelli di iridio spiegabili solo con un corpo contundente extra-terrestre. E che, con sconcerto dell'autrice, è un sito archeologico praticamente clandestino, dove il fortunato passante può staccare e portarsi a casa un pezzo. Le previsioni catastrofiche si moltiplicano. Kolbert ne cita molte ma non vuole sposare un numero, perché le variabili da considerare – in primis il comportamento umano – sono troppe. Il celebre biologo E. O. Wilson aveva proposto una quantità perfetta per i giornalisti: «Nelle foreste pluviali scompaiono 14 specie al giorno». L'autrice, che pure ne dà conto, ricorda però che la valutazione («Diecimila volte maggiore del tasso naturale») è stata poi screditata da alcuni critici: «Molti parlano del 24 per cento delle specie che rischiano di sparire entro la fine del secolo. C'è chi si ferma al 10. Io non do numeri, ma dico una cosa semplice: se continuiamo a pompare queste quantità pazzesche di Co2 nell'atmosfera il primo intero ecosistema a scomparire sarà probabilmente la barriera corallina, già molto malata. Ciò, a cascata, modificherà ulteriormente l'equilibrio biologico sottomarino. Dobbiamo capire che, nel Pianeta, tutto è connesso, tutto ci riguarda».
DAL VOSTRO INVIATO DAGLI ABISSI (SI FA PER DIRE)
Sull’onda dell’entusiasmo avevo deciso di ripercorrere una di quelle storie, immergendomi nelle acque di Ischia (impresa non di poco conto, nuotando io malissimo) dove si vedevano a occhio nudo gli effetti dell’acidificazione degli oceani.
ISCHIA. Il pesce pagliaccio, come certi cocainomani incalliti, non sente più gli odori. Neanche quello dei predatori che potrebbero mangiarselo. È come se avesse il radar guasto, mandato in malora dall'acqua acida. È una delle tante vittime dello stress ambientale che intossica i mari. Per capire il quale non c'è posto migliore che immergersi a poche decine di metri dal Castello Aragonese, splendida fortificazione arroccata su un isolotto collegato a Ischia da un ponte. Perché qui camini vulcanici sotterranei pompano costantemente dell'anidride carbonica nell'acqua, alterandone la composizione chimica. Il Ph medio è già di 7,8, ovvero il livello cui dovrebbe scendere quello degli oceani (oggi a 8,1) entro il 2100, secondo le allarmate previsioni degli scienziati. Gli effetti della versione subacquea del global warming – che ci preoccupa meno solo perché viviamo sulle terre emerse, poca cosa rispetto al 70 per cento di quelle sommerse – qui si vedono con un'anteprima di quasi un secolo. E non è un bello spettacolo.
FAR CAUSA AL GOVERNO? È UN GIOCO DA RAGAZZI
Nell’aprile 2017 invece ero andato in Oregon sulle tracce di una storia che aveva dell’incredibile ma non si è ancora conclusa. Un gruppo di ragazzi, difesi da un’appassionata avvocata, aveva fatto causa all’amministrazione (all’epoca Obama) per non aver fatto abbastanza per proteggere il pianeta. La causa va avanti. Il pezzo iniziava così:
EUGENE (OREGON). Da uno scaffale del suo ufficio monastico («Accendiamo le luci il meno possibile per non sprecare elettricità») Julia Olson tira fuori un libro bianco del novembre ‘65 dal titolo Ripristinare la qualità del nostro ambiente. Commissionato a una squadra di scienziati dall’amministrazione Johnson, avvertiva di rischi tipo l’aumento di un quarto delle emissioni di anidride carbonica entro il 2000 e l’innalzamento di tre metri del livello dei mari. Salvo radicali contromisure. In un’appassionata lettera di accompagnamento, l’allora giovanissimo senatore democratico Daniel Moynihan cercava di rendere più plastico lo scenario a un recalcitrante collega repubblicano: «Ciao ciao New York, ma anche Washington». Di quello stavamo parlando. E di quello parliamo ancora, con la differenza che sono passati inutilmente decenni e a Miami quotidiane mini-inondazioni arrugginiscono i cerchioni delle Porsche e marciscono le fondamenta delle case sul lungomare. Da Venezia a Venice, l’acqua alta è diventata globale.
«Sembra scritto oggi, no?» commenta la quarantacinquenne avvocata che ha deciso di dare la carica all’orologio fermo dell’ambientalismo. Perciò ha fatto causa all’amministrazione Obama, colpevole di non essersi impegnata abbastanza contro il riscaldamento climatico, mettendo così in pericolo il futuro dei suoi ventuno clienti d’età compresa tra gli otto e i vent’anni. E siccome siamo in America, se anche il plot praticamente già pronto per un sequel di Erin Brockovich contro le multinazionali non diventasse un film, di certo diventerà un processo. Ritenuto ammissibile con parole granitiche da un giudice federale il 10 novembre, due giorni dopo che Donald Trump si apprestava a diventare minimizzatore-in-capo del global warming. E definito da Mary Wood, una delle più autorevoli esperte internazionali di diritto dell’ambiente, «la causa che potrebbe salvare il pianeta».
DAL FRACKING AL SOLARE CONCENTRATO
Sul fronte grandi inquinatori ero stato a Williston, in Nord Dakota, capitale del fracking americano, quella tecnica che ha permesso agli Stati uniti di passare (tacendo degli effetti ambientali) da paese in riserva a paese esportatore di petrolio (il reportage, disponibile per tutti, lo trovate qui). Sul fronte energie rinnovabili avevo incontrato Bill Gross, il signore qui sotto, finanziato anche da Bill Gates, che a Pasadena si è inventato un modo nuovo di produrre solare concentrato.
DA LEGGERE: POSSIAMO CAMBIARE IL MONDO
Poche frasi scelte da Possiamo salvare il mondo, prima di cena (Guanda) di Jonathan Safran Foer:
È emblematico che in letteratura il destino del nostro pianeta occupi uno spazio ancora minore che nella più ampia sfera del dibattito culturale, nonostante la maggioranza degli scrittori si consideri particolarmente sensibile alle verità sottorappresentate. Forse il motivo è che gli scrittori sono anche particolarmente sensibili alle storie che funzionano
Non solo la Storia diventa una buona storia a posteriori, le buone storie diventano la Storia.
Il clima probabilmente e l’argomento più noioso che il mondo scientifico si sia mai trovato a presentare al pubblico.
Se la lettera presentava il caso di un soggetto con un nome e un cognome anziché quello di un gruppo anonimo, le donazioni aumentavano del centodieci percento.
Kahneman, uno dei primi studiosi a capire che la nostra mente ha una modalità lenta (deliberativa) e una veloce (intuitiva): « Per mobilitare le persone, questa deve diventare una questione appassionante. Se continuiamo a sentire lo sforzo di salvare il nostro pianeta come una partita fuori casa di metà campionato, non avremo speranza. È evidente che i fatti non bastano a mobilitarci. E se però non riuscissimo a mettere insieme e a sostenere la passione necessaria? Mi sono scontrato con le mie reazioni alla crisi del pianeta. Per me è ovvio che m’importa del destino del pianeta, ma se tempo ed energie investite sono indici dell’importanza di una cosa, è innegabile che m’importa di più del destino di una particolare squadra di baseball, quella della mia città natale: i Washington Nationals. Per me è ovvio che non nego i cambiamenti climatici, ma è innegabile che mi comporto come se li negassi. Permetterei ai miei figli di saltare la scuola per partecipare alla ola di apertura della stagione del baseball, ma non faccio sostanzialmente nulla per impedire che in futuro la nostra città finisca sott’acqua.
DA VEDERE: WATCHMEN
Arriva il Settimo Cavalleggeri, ma non è una buona cosa. Perché si tratta di una milizia incappucciata, di fatto il Ku Klux Klan 2.0. In un futuro vicino l’America si riscopre a rischio. La polizia può andare in giro solo mascherata per evitare rappresaglie personali contro di loro e le loro famiglie. Una di loro, Sister Night, è l’eroina della storia. C’è un Jeremy Irons che gioca a fare Dio. E vari supereroi con limiti molto umani. Questo e altro in Watchmen (Hbo).
DA SENTIRE: STORMY WEATHER
Stormy Weather cantata nel 1956 da Lena Horne (più ruvida della versione celeberrima di Etta James).
Don't know why
There's no sun up in the sky
Stormy weather
Since my man and I ain't together
Keeps raining all of the time.
Epilogo
Per finire una cosa che non c’entra con l’ambiente ma a che fare con un altro tipo di clima impazzito, quello delle relazioni di lavoro. Ce ne occupiamo spesso e ci eravamo illusi che stavolta fosse la volta buona per l’entrata del sindacato nei centri Amazon americani (in quelli italiani, a scanso di equivoci, ci sono) e invece no. In un referendum i lavoratori di Bessemer, Alabama, hanno detto no. Ma ricostruire le tattiche, fino all’intimidazione (lo faccio nell’ultima Galápagos), che l’azienda ha adoperato spiega in parte questo esito. Ma come diceva il vecchio Yogi Berra, sfidando la tautologia, it ain’t over till it’s over.