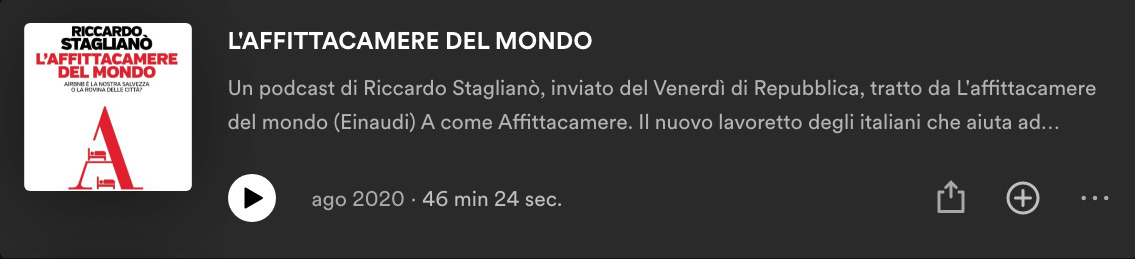#98 Frenare Airbnb (magari è la volta buona)
Anche a Bozeman, nel loro piccolo, si incazzano; vogliamo davvero diventare l'affittacamere del mondo; sui prezzi di Milano c'entrano anche gli affitti brevi
ARTICOLI. LIBRI. VIDEO. PODCAST. LIVE. BIO.
Prologo
Nel mezzo del lockdown, con un tempismo che mi ha candidato al Premio Charlie Brown per la sfiga editoriale, è uscito L’affittacamere del mondo (Einaudi), un libro che provava a mettere in guardia su come Airbnb stava cambiando le nostre città (no, non per il meglio). Dopo tre anni, quando la gente ha ripreso a viaggiare, il tema torna di attualità. Proverò a convincere l’editore a ripubblicarlo, magari solo in ebook, con nuova introduzione.
LA RIVOLTA DI BOZEMAN
Dall’ultima Galapagos:
Bozeman è un'incantevole cittadina del Montana, a un'ora e mezzo di auto dal confine settentrionale di Yellowstone, il parco di Yogi nonché la location dell'omonima serie con Kevin Costner nei panni del cowboy cattivo. Ci sono stato qualche mese fa per intervistare David Quammen, l'uomo che aveva visto arrivare il Covid. Il luogo è la quintessenza della rilassatezza e della pace sociale. Sorprende dunque che, in un fredda serata di febbraio, circa 300 abitanti (su una popolazione di 54 mila) si siano dati appuntamento in una chiesa locale per chiedere il bando totale degli affitti brevi. Perché se nei prossimi dieci anni investitori e forestieri continuano a comprare case per ricchi vacanzieri, ha dichiarato Benjamin Finegan a Insider, «non ci sarà più Bozeman». Un'immobiliarista presente ha stimato che circa la metà delle case, già adesso, appartengano a persone che non vivono in città. E quindi le affittano su Airbnb o piattaforme analoghe (negli ultimi tre anni gli annunci sono passati da 500 a 900 stando a AirDNA). Nello stesso intervallo i prezzi delle case sono aumentati del 40 per cento e l'affitto medio di un bilocale è quasi raddoppiato, passando da 1000 a 1975 calcola Zumper. Il problema è antico. La differenza è che, dopo aver travolto città d'arte e metropoli turistiche, ora attacca anche l'America interna. Il rubrichista qui se n'era occupato in un libro uscito durante il lockdown, col tempismo peggiore della storia editoriale (e in un podcast sul nostro sito). Ma ora il tema torna anche nel dibattito italiano, con i sindaci da Firenze, Bologna e Milano che provano a correre ai ripari. Viareggio, per dirne una, ha gli abitanti di Bozeman e solo il 18 per cento in meno di annunci. Ma nessuno protesta. A calma zen non ci battono neanche sulle Montagne Rocciose.
L’AFFITTACAMERE DEL MONDO
Di seguito buona parte del Prologo del libro:
Soprattutto per i millennials, i nati tra l'81 e il '96, comprare casa è diventato un miraggio. Nessuna banca da un mutuo a gente che non ha mai visto una busta paga tradizionale. Ma la precarietà del lavoro va ben oltre la loro tribù demografica e, anche negli anni ottimisti del Jobs Act (o meglio, della decontribuzione per chi assumeva), a crescere erano stati i contratti a tempo. Buoni per campare, meno per metter su famiglia. La proporzione aurea di quanti soldi dovrebbero servire, al massimo, per assicurarsi un tetto sulla testa è di un terzo di quanto si guadagna. Oggi, il più delle volte, ne va via la metà. Con aberrazioni anche peggiori per cui a San Francisco, la città con gli affitti più alti d'America anche per l'afflusso record di nuovi ricchi dalla vicina Silicon Valley, giusto chi guadagna almeno 172 mila dollari all'anno può comprarsi casa in città (prezzo mediano 1 milione e cento) senza dover riparare in qualche sobborgo. Folle, no? Ero andato a parlare dell'idea del libro con Andrea Brandolini, un intellettuale che di mestiere fa il capo della statistica della Banca d'Italia. Aveva invitato anche due suoi colleghi, Matteo Bugamelli e Alfonso Rosolia, con cui ha firmato vari studi e che sono quel tipo di civil servant che funzionano da bene rifugio mentale quando il Paese sembra andare più a ramengo del solito. A un certo punto la conversazione si era spostata su un articolo su cui avevo appena finito di lavorare, ovvero l'ipertustificazione di Firenze e il ruolo che Airbnb aveva giocato nell'intensificarsi del fenomeno. Avevo scelto il capoluogo toscano in quanto primatista nazionale nel rapporto tra case offerte sulla piattaforma e patrimonio immobiliare totale. Limitandosi al piccolo e prezioso centro storico la quota era del 25 per cento: un proprietario su quattro, a quanto pare, a un certo punto si era riciclato nel settore ospitalità. A me faceva molta impressione, ai miei commensali meno. D'altronde quello della bellezza culturale e paesaggistica, mi hanno spiegato, è una sorta di monopolio naturale, l'ultimo asset importante che possiamo sfruttare. Aggiungete che poco meno dell'80 per cento degli italiani ha una casa di proprietà. Avevano fatto due rapidi conti sulla minuscola percentuale di cinesi, appena promossi nella classe media, che aveva cominciato a viaggiare: già solo con quelli ancora sulla rampa di lancio del decollo sociale avremmo potuto andare avanti decenni. E c'era tutto il resto del mondo che sognava di visitare il Belpaese. «Ma non vi sembra triste la prospettiva di diventare l'affittacamere del mondo?» avevo obiettato. «Dici che è meglio, come nel caso di Londra, una monocoltura finanziaria? Non ne sarei certo». Caffè, conto e saluti.
Le contraddizioni della sharing economy
Tanto laicismo mi aveva colpito. Parliamo di tre economisti molto sofisticati, che hanno studiato a fondo la disuguaglianza e probabilmente la metterebbero al primo posto tra i problemi della società. Agli antipodi della tendenza «lupo di Wall Street», per intenderci. Dal canto mio, l'ultimo libro che ho scritto è un attacco ad alzo zero contro la retorica della cosiddetta sharing economy. Che non nasce dal desiderio di condividere alcunché ma dalla disperazione economica di legioni che, dopo la Grande recessione del 2007-2008, avevano sempre più difficoltà ad arrivare a fine mese. Se avevi perso il posto (la disoccupazione era di colpo raddoppiata) o avevi avuto il salario ridotto e quindi eri stato costretto a intaccare i risparmi (dimezzati in quegli anni) o, peggio, ti eri dovuto indebitare, non potevi fare lo schizzinoso: un lavoretto non era un granché, ma decisamente meglio di niente. Airbnb aveva un capitolo tutto per sé. Finché non c'era stato bisogno nessuno avrebbe mai pensato di mettere all'asta la camera in più, ma adesso era diventato facile e soprattutto ogni soldo in più contava. Quanto alle tasse l'azienda condivideva con la più muscolare Uber un cinismo assoluto quando si trattava di pagarle. Con triangolazioni legali ma non per questo meno immorali che facevano sì, per dire, che ancora pochi anni fa versasse al fisco in Francia, il suo secondo mercato mondiale, quanto un solo cittadino abbiente.
Mia madre e Paola
Nel frattempo, però, era successa anche un'altra cosa. Mio padre era morto e mia madre aveva cominciato ad affittare nei mesi estivi, proprio attraverso Airbnb, una parte della sua casa a Viareggio. L'attività si era rivelata un toccasana: la teneva impegnata e la distraeva dal pensiero ricorrente del lutto. Da giugno ad agosto era stata quasi sempre piena e nella prima stagione aveva incassato circa 8000 euro, che diventavano poco più di 6000 al netto delle tasse. Come se non bastasse, per una donna che aveva sempre fatto la casalinga e non si era mai misurata con l'esterno quanto a gratificazioni professionali, riscuoteva un enorme successo tra gli ospiti che facevano a gara a chi le lasciava le recensioni più entusiastiche. Così aveva conquistato lo status di Superhost, un bollino di eccellenza che rende il tuo annuncio più visibile tra i risultati. Cosa avevo da obiettare, esattamente, contro la piattaforma che aveva reso possibile tutto ciò? Se la prova che avevo in famiglia non fosse bastata, ce n'era un'altra esterna. Stavolta riguardava Paola, una mia amica insegnante di italiano in una scuola media della prima periferia romana. Dopo diciannove anni di anzianità, come tutti i suoi colleghi, guadagnava 1450 euro. Che andavano via alla svelta per pagare il mutuo che molti anni prima aveva acceso per comprarsi i novanta metri quadri vista binari sulla Casilina in cui originariamente sarebbero dovuti andare a vivere in due. La soluzione, sin dall'inizio, era stata di affittare ogni tanto la stanza in più con il passaparola. Poi su proto piattaforme di cui si è persa la memoria. Infine era arrivata Airbnb e il suo secondo lavoro era decollato. Negli ultimi cinque anni, a una quarantina di euro a notte, ha avuto ospiti per una media di ottanta giorni l'anno nei primi tre per arrivare a centocinquanta negli ultimi due. Ci ha pagato le tasse, esultando per la cedolare secca al 21 per cento. Essendo di sinistra e con un senso forte etico capisce perfettamente le obiezioni sui potenziali danni collaterali dell'attività di cui pure è protagonista. Pretende però che si facciano distinzioni: «Una cosa sono i latifondisti che ne gestiscono decine sottraendole al mercato residenziale, altra quelli come me che affittano un pezzo di casa propria per arrotondare. Mi sembrerebbe un grave errore prendersela con questa forma di ammortizzatore sociale». Già.
E infine io
Più pensavo a loro, più andavo in crisi io. Perché erano entrambe testimonial perfette, versante utenti, del lato buono della piattaforma. Mettevano a reddito il capitale più cospicuo che avevano: a chi facevano male? In verità la domanda me l'ero già fatta nel libro precedente e mi ero anche dato la risposta: ad esempio agli alberghi. Chi dormiva da loro non dormiva in hotel. All'epoca c'era un solo studio su Austin, in Texas, che parlava di una riduzione tra l'8 e il 10 percento nei fatturati dei tre stelle a causa di Airbnb. Poi ne sono arrivati vari altri, meno perentori, con cui familiarizzeremo nei prossimi capitoli. Di certo però mamma e Paola non toglievano case dal mercato residenziale contribuendo a far alzare il prezzo degli affitti. Almeno versante azienda tenevo il punto: la loro strategia fiscale era odiosa, tanto più intollerabile dal momento che si raccontavano come un soggetto che aveva a cuore le sorti delle comunità dove operava (e allora cominciate a pagare le tasse come tutti, se ci tenete!). Per contrastare la resistenza che nel mondo cresceva erano andati a pescare i propri lobbisti nelle file degli ex consulenti di presidenti degli Stati uniti. Ma dal punto di vista di chi la usava, sia per viaggiare low cost che per ospitare e integrare i redditi, facevo sempre più fatica a condannare. L'ultimo carpiato della coscienza l'avevo sfiorato pensando a dove mettere i miei risparmi. In banca, dove lentamente si accumulavano, non producevano niente. La Borsa è troppo rischiosa, serve un altro fisico. L'unica, alternativa come da tradizione italica, restava il mattone. Ma anche lì le storie dell'orrore abbondavano, con il proverbiale inquilino che non pagava da mesi e c'era voluta la forza pubblica e due anni di attesa per cacciarlo, più sei mesi di lavori per aggiustare quello che aveva scassato. «L'ideale è metterla su Airbnb» mi aveva detto, come se tutto il resto fosse ragionevole quanto fare da bersaglio per un lanciatore di coltelli ubriaco, un agente immobiliare romano, munito di cravatta con nodo a ormeggio d'ordinanza. Non avevo neanche osato accennare al rovello etico che ciò avrebbe fatto deflagrare nel fiero autore di Lavoretti e avevo abbozzato. Però avevo giurato di rifletterci meglio, nel più distaccato modo possibile, ed è in quel momento che l'idea del libro che avete tra le mani ha sfrattato quella originaria, con cui pure ha in comune la povertà come scaturigine.
Bene o male: dipende a chi chiedi?
Alla svolta, in verità, avevano contribuito altri fattori la cui casuale moltiplicazione tendo spesso a interpretare come segni del destino. Cominciandone a parlare in giro, ancora ai tempi in cui avevamo dedicato una copertina del Venerdì all'overtourism di Firenze, avevo scoperto che tra me e qualcuno che affittasse su Airbnb c'era in media un grado di separazione. Il fratello della collega. Il conoscente dell'amico. Il compagno di classe dell'ex fidanzata. Bastava pronunciare la parola magica e il grafo dei partecipanti dell'economia che le era cresciuta intorno si infittiva esponenzialmente. Guardando la tv mi ero imbattuto in uno spot di CleanBnb, una delle tante aziende che promettono di togliere qualsiasi preoccupazione all'aspirante locatore: tu gli dai le chiavi, loro ti danno i soldi, al netto della commissione. Cosa c'è di strano? Che solo i business digitali molto sicuri di sé si permettono la pubblicità televisiva. Poi avevo letto di San Francisco, la città in cui Airbnb è nata, oggi tra le più dure al mondo quanto a limiti imposti alla piattaforma. Di New York, la città dove letteralmente ogni affare è possibile, che di fatto proibisce affitti inferiori ai trenta giorni, per evitare una concorrenza troppo sleale con gli hotel. E poi continuavano a ronzarmi in testa le parole dei comitati fiorentini, animati da fortunatissimi residenti del centro storico, che si lamentavano della loro condizione come se vivessero in uno slum. Per non dire dei loro esponenti più politicizzati, decisamente a sinistra, che vedevano a dieci decimi i rischi di incrementi turistici collegati alla piattaforma mentre sembravano assolutamente ciechi di fronte alla funzione di sussidio ai redditi che pure assolveva. Tacendo dell'indotto di check-in e pulizie che nelle città d'arte è diventata l'alternativa contemporanea al call center di solo alcuni anni fa. Per non menzionare che, nel 2017, i turisti internazionali sono stati 1,3 miliardi, in aumento del 7 percento rispetto all'anno prima e che l'agenzia delle Nazioni Unite sul turismo (UNWTO) prevede che per il 2030 supereranno i 2 miliardi. E il turismo domestico, quello interno alle nazioni, è cinque volte più grande. A coronamento di tutto questo il termine overtourism per la prima volta è entrato nella finale delle parole dell'anno dell'Oxford Dictionary. Descrive una soglia superata la quale gli ospiti stroppiano e la qualità della vita della città peggiora per tutti. C'entrava anche Airbnb (e Booking, e HomeAway, e tutte le altre piattaforme dell'ospitalità di cui la prima è diventata vox media), ma quanto? Toglievano agli hotel o creavano una nuova offerta, aumentando il totale? Il viaggio che segue, tra Italia, Europa e Stati uniti, è il tentativo più intellettualmente onesto di cui sono capace di provare a rispondere ad alcuni di questi quesiti.
IL PODCAST
Dal libro avevo ricavato anche un podcast, che trovate qui.
MILANO FUORI CONTROLLO
Nelle settimane scorse ho scritto dei prezzi delle case di Milano sempre più fuori controllo. Lucia Tozzi, autrice di L’invenzione di Milano, diceva questo:
Ancora Tozzi: «Aggiungo che altri 90 mila appartamenti, quelli comprati dalla buona borghesia del sud per investimento in attesa che servano al figlio universitario, restano vuoti. La mia proposta è di tassarli, inclusi quelli su cui i proprietari fanno Airbnb. Insomma, ostacolare la rendita se si vuole rapidamente rimettere sul mercato un sacco di unità immobiliari per i residenti e non per i turisti». Incontestabile è che il nostro Paese, terzo mercato mondiale di Airbnb, sia tra i pochi che non prevede limiti alla sua adozione, quando anche a San Francisco, dove la formula è nata, si può affittare solo la casa in cui si vive.
Epilogo
Fuori sacco uno sconsiglio dalla newsletter del Venerdì:
Alla fine, ma va là, anche Roy Logan muore. Il tycoon metà Rupert Murdoch e metà Re Lear, che aveva aperto la prima stagione di Succession rischiando di tirare le cuoia, nella quarta le tira davvero. E come allora la possibilità aveva mandato in ipersalivazione i figli, pronti a scannarsi per prenderne il posto nell'impero mediatico, adesso le spoglie sono da dividersi per davvero. La forza della serie era nel livello di cinismo spaventoso, ma così probabilmente realistico presso certi casati ultraricchi, che non si vergognava a mettere in scena. Però il cinismo, come la droga, prima eccita poi crea assuefazione. La baruffe chiozzotte tra rampolli plutocrati, talvolta parecchio scemi, e la corte di famigli che gli gira intorno sono, alla lunga, sempre uguali a se stessi. Il meccanismo, pur benissimo scritto, è drammaticamente prevedibile. Nella veglia funebre l'unico personaggio che spicca è l'ex moglie del patriarca, sparita dalla sua vita, che d'improvviso riappare e assicura tutti che non si erano mai persi di vista. E nel farlo, tra una lacrima artificiale e una tartina, vende per 63 milioni di dollari l'appartamento paterno al figlio meno dotato. Siglando l'affare con uno sputo sulla mano.
Così così.