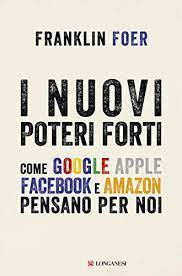#9 L'opera d'arte nell'epoca degli Nft
Perché 20-21?; l'ossimoro del pezzo unico digitale; i bitcoin spiegati facile; la verità, vi prego, su McKinsey; Silicon Valley v. diritto d'autore; in morte di un fattorino; Jobim&Regina
ARTICOLI. VIDEO. PODCAST. LIBRI. LIVE. BIO.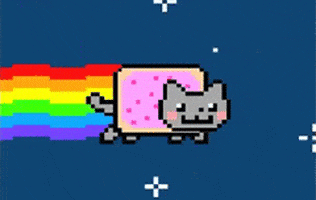
Prologo
Tra gli smottamenti linguistici che si sono intensificati nell’ultima settimana c’è il ribattezzare all’americana il modo in cui si dicono gli anni. Per Amadeus, quindi, non è stata l’edizione duemilaventuno di Sanremo ma la venti-ventuno. Per il ministro della transizione tecnologica Vittorio Colao l’orizzonte del cambiamento non è il duemilatrenta ma il venti-trenta. Fa un po’ sorridere. Come il ripetere di tanti colleghi, ostentando familiarità con il gergo dei consulenti d’impresa (di più sotto), che l’importante è la «messa a terra» dei progetti. I luoghi comuni sono tutti un po’ tristi. I più tristi di tutti son quelli che si prendono sul serio. Il mio sogno, da una ventina d’anni abbondanti, sarebbe fare una rubrica come la magnifica On Language che il leggendario William Safire teneva sul New York Times Magazine e che, dei topoi emergenti, risaliva alle origini (la prima volta che l’espressione era stata usata, in quale contesto, com’era cambiata nel tempo, etc). Ma il problema è che, oltre a non essere io Safire, in Italia non esistono banche dati lessicografiche per ristabilire tutta questa cronologia. Magari in futuro. Chissà.
NFT, PEZZI UNICI NELL’ERA DELLA RIPRODUCIBILITÀ TECNICA
La mia rubrica Galápagos è dedicata all’ultima – in attesa della prossima, che non tarderà – follia dalla Silicon Valley: gli Nft. L’acronimo sta per Non fungible token, pezzi unici digitali, per così dire.
Così Jack Dorsey, il fondatore di Twitter, ha messo all'asta sul sito Valuables by cent il suo primo tweet, datato 21 marzo 2006, in cui scriveva «just setting up my twttr». L'offerta più alta, da parte di un altro manager tecnologico, è stata di 2,5 milioni di dollari (tendenzialmente si paga in criptovalute). Ma in cambio di cosa? Di diventare il padrone del tweet, con una transazione registrata irrevocabilmente sulla blockchain (il grande registro elettronico che è anche alla base dei bitcoin), con un certificato digitale crittografato, e quindi di fatto trasformare quelle cinque paroline in un pezzo unico. Una volta che te ne sei impadronito puoi decidere, come se fosse un'opera d'arte, di esporlo, rivenderlo, farci quel che vuoi.
Ora, è probabilmente l’estensione del dominio della lotta de L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica, il saggio che Walter Benjamin scrisse nel ‘36, ma mi ha fatto comunque impressione come esempio parossistico dello scollamento tra valore d’uso e di scambio delle merci. Compreso scoprire che Mike Winkelmann, in arte Beeple, ha venduto vari pezzi su Christie's ed è diventato famosissimo dopo che un collezionista di Miami (che a ottobre scorso l'aveva comprato a 67 mila dollari) ha rivenduto un suo video da 10 secondi per… 6,6 milioni (mi voglio rovinare e ve lo regalo). E che il popolarissimo meme sul gatto di Nyan, inventato da questo ragazzo qui, è stato rivenduto per 590 mila dollari. Ma che vuol dire “vendere” e “possedere” quando la rete è lastricata, a partire dall’apertura di questa newsletter, di copie conformi? Il dibattito è aperto.
I BITCOIN SPIEGATI A MIA MADRE
La vicenda degli Nft ne incrocia un’altra. Quella del modo in cui quest’arte, o comunque vogliamo chiamarla (penso al tweet smozzicato di Dorsey), viene pagata, vale a dire con qualche tipo di criptovalute. Qualche anno fa, dopo aver iniziato la lettura poi puntualmente abbandonata di decine di articoli sul tema, mi ero intrepidamente tuffato in questo mondo esoterico. La spinta iniziale, come spesso succede, aveva un addentellato personale. Nel 2014, all’Internet Festival di Pisa, avevo cambiato 10 euro in un bancomat per bitcoin per documentare poi di come questo investimento sarebbe andato nel tempo. Ma poi, quando era arrivato il momento di scriverne, il wallet che conservava il mio peculio non c’era più perché il mio vecchio telefono era andato a mia madre, non trovavamo più le password ed è stata un’avventura recuperarle (c’è gente che, non riuscendoci, ha perso milioni). Il risultato fu una copertina del Venerdì dal titolo I bitcoin spiegati a mia madre (lo dico subito alla polizia morale: non era l’ennesimo, odioso esempio di mansplaining, ma banalmente il fatto che mio padre era appena morto e non avevo altri anziani a portata di mano cui provare a spiegarlo). Se siete tra i tanti che avreste voluto capirne qualcosa e vi siete sempre arresi una volta varcato l’uscio, questo è il pezzo che fa per voi (spero). Estratto su “cosa sono”:
Come su Napster o su BitTorrent, dove ci si scambiano film o musica da persona a persona, qui si scambia questo inedito denaro. A evitare che qualcuno faccia il furbo e provi a spendere la stessa somma più volte ci pensa un’infrastruttura informatica che si chiama blockchain. La sua caratteristica principale è di essere una banca dati distribuita su tanti computer la quale tiene traccia di ogni transazione. Immaginate, tagliando con l’accetta, un enorme registro contenuto in un file che diventa più pesante, come un documento di Word a cui aggiungi del testo, ad ogni nuova compravendita (oggi è sui 150 Gigabit, ovvero 150 volte i 44 volumi della Enciclopedia Britannica).
Quel super file si trova fisicamente replicato su oltre 12000 nodi, ovvero computer, nel mondo. Ogni 10 minuti tutti i passaggi di bitcoin, per pagare una pizza come un container di droga, avvenuti in quel lasso di tempo, vengono impacchettati per formare un block, un anello della catena che per essere valida deve essere continua, senza interruzioni. Detto altrimenti: ogni blocco è come un’automobilina, con una targa sul davanti e una sul dietro che devono corrispondere a quelle del blocco precedente e di quello successivo. A certificare, attraverso complessi calcoli matematici, che tutto ciò avvenga senza alterazioni pensano i membri della comunità. Di cui Fausto Soriani fa parte.
E su “come si creano”:
Questa febbrile attività si chiama mining, estrazione, e la compiono in automatico dei software. L’allusione mineraria è piuttosto pertinente perché, proprio come nella corsa all’oro del Klondike, le ricompense si riducono col tempo e con l’arrivo di nuovi cercatori. All’inizio, nel lontano 2010 in cui il misterioso Nakamoto minò da solo circa un milione di bitcoin, la metà di quelli allora esistenti, chi si aggiudicava per primo, in una sorta di asta planetaria, la certificazione di un blocco, veniva retribuito dal sistema con 50 bitcoin. Una parcella che è già scesa a 12,5 bitcoin e continuerà a dimezzarsi man mano che ci avvicineremo al limite massimo di bitcoin in circolazione (21 milioni, contro i 17 attuali, la soglia pensata nelle specifiche originarie per evitare rischi di inflazione).
Il compenso, a scanso di equivoci, non va a una singola persona ma a una squadra di miners, anche varie migliaia, che mettono insieme la potenza di calcolo dei propri computer per poter eseguire le operazioni matematiche che individuano la proof-of-work, la firma numerica che invera tutta la sequenza.
Seguono 200 righe o giù di lì che trovate nel pezzo integrale.
MCKINSEY, O DEL GOVERNMENT AS-A-SERVICE
Ha fatto discutere la decisione del ministero dell’economia di reclutare uomini di McKinsey, la più celebre azienda di consulenza strategica al mondo, per aiutare nella redazione del Recovery Plan. È stato fatto notare che, come testimonierebbe il modestissimo pagamento, si tratterà solo di lavoro tecnico, specializzato ma di manovalanza (di fatto, ragazzi bravi con Excel e i diagrammi di Gantt che servono per visualizzare lo stato di avanzamento dei progetti). C’è chi dice che c’è un bel problema se la Pa non ha all’interno figure professionali del genere. C’è chi l’ha buttata in caciara accusando di complottismo chiunque avanzasse dubbi. Intanto in America, dove McKinsey ha preso 100 milioni di dollari per aiutare nella gestione del Covid, c’è chi chiede conto della pessima performance (per non dire dei 600 milioni che ha accettato di pagare per il suo ruolo nell’epidemia da oppioidi). Idem in Francia dove di milioni di euro ne ha presi solo 4. Tutto questo per dire che ce n’è abbastanza per fare domande e intavolare un dibattito anche da noi. Sulla falsariga del vecchio Spinoza quando ammoniva: non ridere né piangere ma comprendere. Magari ci proveremo.
DA LEGGERE: I NUOVI POTERI FORTI
Per assonanza di titolo, e per ragionamenti sulla proprietà intellettuale al tempo della rete, ripesco questo I nuovi poteri forti (Longanesi) in cui Franklin Foer (primogenito del trio di fratelli: Jonathan Safran, lo scrittore e Joshua, il mnemotecnico. Domanda: cosa gli hanno dato da mangiare da piccoli?) racconta il suo disamoramento rispetto al tycoon tecnologico che avrebbe dovuto salvare la rivista The New Republic e ha finito per affossarla, almeno per gli standard di Foer.
I suoi successori – Facebook, Google, Apple – non sono caduti nello stesso tranello e sono riusciti a superare Microsoft grazie a un approccio rivoluzionario: dominare i media senza assumere scrittori e redattori, senza possedere quasi nulla.
«Quando sono costretto a leggere un libro fisico mi irrito, perché è scomodo girare tutte quelle pagine... e i libri si chiudono sempre da soli al momento sbagliato». (Jeff Bezos)
La gente paga per avere automobili o case perché si tratta di prodotti dalla disponibilità limitata, oppure perché possiedono la qualità che Paul Romer, l’economista che più ha riflettuto sulla conoscenza, chiamava «rivalità»: se io possiedo un badile, non puoi avere lo stesso badile anche tu. Questo tipo di rivalità non può mai essere valido per la conoscenza: sì, creare un nuovo seme o finanziare una lunga inchiesta di giornalismo investigativo è molto costoso, ma una volta completata la ricetta o pubblicato l’articolo, il prodotto può essere replicato in maniera gratuita, o quasi.
Se lasciato in balia dei meccanismi di mercato, il prezzo della conoscenza crollerebbe rapidamente, abbattuto dalla semplicità con cui essa può essere riprodotta gratuitamente. Il governo, però, non permette che questo accada, poiché una delle sue principali responsabilità economiche è salvaguardare il valore della conoscenza, mettendo i creatori di conoscenza al riparo dalle difficoltà del mercato competitivo e garantendo loro un temporaneo monopolio a sponsorizzazione statale mediante brevetti e diritti d’autore.
Il giornalista Robert Levine ha scritto che «A Google i contenuti online gratuiti stanno a cuore come la benzina a prezzi bassi sta a cuore alla General Motors. Per questo l’azienda spende milioni di dollari in attività di lobby per indebolire il diritto d’autore»
Per ogni articolo pubblicato, Upworthy scriveva venticinque diversi titoli; tramite un software poteva pubblicarli tutti automaticamente e verificare quale fosse il piu` cliccabile del lotto. Studiando questi risultati, Upworthy aveva individuato dei modelli sintattici che tendevano a garantire il successo.
La Silicon Valley ha dichiarato guerra agli scrittori professionisti e mira a indebolire le leggi sul diritto d’autore che consentono loro di guadagnarsi da vivere con ciò che scrivono.
La Authors Guild ha svolto un sondaggio fra i suoi membri, scoprendo che gli scrittori a tempo pieno guadagnavano in media 11.000 dollari all’anno, pari oggi, tenuto conto dell’inflazione, a 35.000 dollari. La cifra non sembra molto alta, ma lo è se la confrontiamo con i risultati ottenuti dalla Authors Guild nel 2009, che indicavano un reddito medio di 25.000 dollari. Purtroppo però, questo valore e sceso ulteriormente, in una spirale di deflazione che ha portato il reddito medio a 17.500 dollari nel 2015. (…) Nell’arco di trentacinque anni, gli scrittori hanno subito un taglio del 50% dello stipendio, e il reddito attuale si trova poco al di sopra della soglia di povertà stabilita ufficialmente dal governo.
Per salvarsi, i media dovranno far pagare i lettori, e i lettori dovranno iniziare a pagare.
DA VEDERE: COLLATERAL
In attesa di momenti migliori (la sesta e ultima stagione di Better Call Saul, per dire), bisogna accontentarsi di quel che passa il convento. Collateral, sull’omicidio di un fattorino che porta la pizza ma che aveva “colpe” pregresse, si difende bene. Bel tipo la detective, soprattutto. Su Netflix.
DA ASCOLTARE: AGUAS DE MARÇO
Non c’entra niente, tranne che è marzo e rischia di piovere nel fine settimana e faccio gli scongiuri che non piova, ma guardatevi questo duetto di Aguas de março del ‘74. È un climax di godimento, Tom Jobim e Elis Regina (sublime, sventuratamente morta nell’82, a 36 anni) si divertono sempre più, sopratutto verso l’irresistibile finale. A Rio andai all’Espaço Tom Jobim sulle elusive tracce di quella capacità di essere contenti delle cose che si fanno, mentre si fanno. Francis Scott Fitzgerald ha avuto molte ragioni, ma si sbagliava di grosso quando scriveva ne Il crollo che «di tutte le forze naturali, se ce n'è una che non si trasmette è la vitalità».