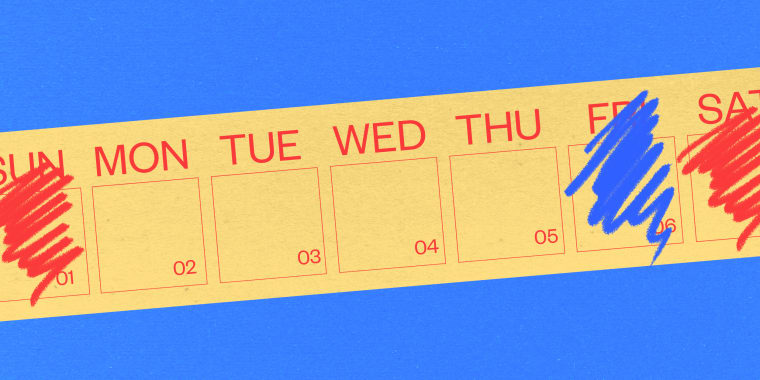#64 Se quattro giorni vi sembran pochi...
Di settimana corta si parla in tutto il mondo tranne che in Italia: perché?; il punto di vista degli accelerazionisti; Californie
ARTICOLI. LIBRI. VIDEO. PODCAST. LIVE. BIO.
Prologo
La buona notizia è che i lavoratori americani di Amazon a Staten Island, per la prima volta, sono riusciti a sindacalizzarsi. È una svolta. Intanto da noi Amazon sospende una dipendente rea di aver fatto una pausa-pipì troppo lunga (dice Amazon: alla terza pausa ingiustificata). Fortunatamente c’erano i sindacati, hanno denunciato l’accaduto e l’ispettorato del lavoro ha annullato la sanzione.
OTTO ARGOMENTI PER LA SETTIMANA CORTA
Nel servizio di copertina del Venerdì intervisto l’economista Pedro Gomes, uno dei più convincenti sostenitori della settimana di quattro giorni. Un estratto:
Insomma, a giudicare da questo piccolo campione, qualcuno se la gode di più o semplicemente tira il fiato ma tanti hanno invece incanalato qualche energia residua su possibili piani B resi impraticabili dal full time. Quello dell’occasione per sprigionare creatività è uno degli argomenti forti di Pedro Gomes, economista portoghese al Birkbeck dell’università di Londra (ci studiò il giovane Marx) e autore di Friday Is the New Saturday, una specie di manifesto a favore della settimana breve. «Nella storia dell’economia molta innovazione è scaturita fuori dal posto di lavoro» dice in collegamento Zoom: «Henry Ford concepì da casa il motore delle sue auto. Steve Wozniack inventò il Mac nelle pause dal suo lavoro principale. Phil Knight ha concepito le Nike mentre aveva un altro negozio. J. K. Rowling ha creato Harry Potter in quel che restava dalle sue giornate come insegnante. È nel tempo libero mentale che le idee migliori vengono alla luce».
Il suo libro, che arruola alla causa pensatori di sinistra come di destra, rappacificando Keynes con Hayek, squaderna otto argomenti in favore del cambiamento. Gli giro subito qualche obiezione standard che, in passato, hanno strangolato in culla il nostro dibattito: abbiamo una bassa produttività, come potremo permetterci di lavorare meno? «È vero il contrario! Con produttività si intendono due cose distinte: la quantità di output, beni o servizi, che un singolo lavoratore produce in un’ora ma anche il totale della produzione di un Paese. Nella prima accezione, se abbassate il denominatore (ore) il numeratore (prodotto) aumenta. E un lavoratore più riposato fa meno errori, riduce il turnover – che è un costo –, si dà meno malato. Ma anche nella seconda accezione c’è un miglioramento. Perché la produttività di ristoranti, alberghi, cinema vuoti è bassissima. Se organizziamo la settimana allungando il weekend questi luoghi vedranno molti più clienti. Insomma, bisogna guardare all’economia nel suo complesso». Non la mette in difficoltà neppure la nostra spaventosa percentuale di disoccupazione giovanile che fa dire allo scettico: “servono più ore, per questi ragazzi, non meno”? «Anche qui bisogna guardarsi dall’apparente buon senso, sollevando lo sguardo. L’industria del tempo libero, particolarmente rilevante da voi, impiega molto personale giovane o temporaneo: l’aumento dei consumi li favorirà indirettamente creando maggior domanda. Aggiungo un gran tema per l’Italia: quello della scarsa natalità. Con uomini e donne che lavorano non c’è tempo né per pensare né, sembra una sciocchezza ma non lo è, per praticare il sesso: un ribilanciamento di orari gioverebbe anche a quello». L’ultimo argomento è quello della riconciliazione di una società sempre più polarizzata: «Quando Roosevelt varò, col New Deal, la settimana di cinque giorni l’America si sbarazzò del populismo per cinquant’anni. I Trump e Bolsonaro prosperano in un clima dove i diritti dei lavoratori fanno passi indietro invece di progredire».
LA RICETTA DEGLI ACCELERAZIONISTI
Qualche anno fa avevo recensito un libro che, non solo sui tempi ma anche sulla necessità del lavoro andava decisamente all’attacco. Dal momento che non l’avevamo messo online lo ripropongo qua:
Roma. «Non è il lunedì che detesti, è il tuo lavoro» recita uno dei capitoletti di Inventare il futuro di Nick Srnicek e Alex Williams (Nero Editions, pag. 362, e. 17), ricombinando la saggezza popolare stampigliata su tante t-shirt. La buona notizia, dal loro punto di vista, è che il lavoro ha i giorni contati. Sarà sostituito dalle macchine, come mette in guardia da qualche tempo una letteratura sempre più copiosa. I due autori però si staccano dal mucchio dei preoccupati in una fuga baldanzosa: non dobbiamo temere il rimpiazzo, dobbiamo invocarlo, desiderarlo, pretenderlo. Perché la piena automazione farà esplodere le contraddizioni del capitale e ci condurrà trionfalmente verso un nuovo umanesimo. Traghettandoci, per dirla con due immagini care a Marx, dal «regno della necessità» al «regno della libertà». Destinazione mitologica, dal tragitto accidentato, con un mezzo di locomozione che non convince chi scrive ma che vale la pena di prendere sul serio.
Srnicek e Williams, giovani scienziati sociali della scena londinese, avevano fatto già parlare di sé pubblicando nel 2015 il Manifesto per una politica accelerazionista in cui anticipavano alcuni dei temi parzialmente sostenuti anche in Postcapitalismo, il fortunato volume di Paul Mason. Il loro saggio aveva finito per suscitare più entusiasmo a destra che a sinistra e forse questo spiega perché nelle trecento e passa pagine del libro odierno non figura mai la parola accelerazionismo, che è un po’ come se il filosofo di Treviri, dopo aver dato alle stampe il suo Manifesto, avesse espunto «comunismo» dalla produzione successiva. Ma tant’è.
La sinistra ha bisogno di un nuovo schema di gioco, sostengono gli autori. All’attacco. Basta con il «reagire (alle azioni delle aziende o del governi); ignorare strategie di lungo termine rispetto alle tattiche; scegliere la familiarità del passato rispetto all’ignoto del futuro (ad esempio con gli insistiti sogni di un un ritorno al «buon capitalismo keynesiano»)» e basta con tanti altri errori tutti nel segno del difetto. Se anche dovessimo sbagliare, che almeno sia per eccesso. Il futuro era, alle origini, il territorio di caccia della sinistra. Poi, a un certo punto, se l’è fatto scippare dal neoliberalismo. Ma contro un avversario così consolidato («Una moratoria sull’uso del termine aiuterebbe a solidificare di molto un dibattito gassoso» nota, ferocemente quanto irresistibilmente un recensore del New Yorker) bisogna mettere in campo una «controegemonia gramsciana», saper pensare un «futuro iperstizionale», dove iperstizione è «una specie di finzione che ambisce a trasformarsi in realtà», «catalizzando un sentimento diffuso per poi tramutarlo in una forza storica che porta il futuro a verificarsi: la loro forma temporale è il “sarà stato”» (Sì, i due hanno un debole conclamato per un lessico deleuze-gattariano). Per dirla altrimenti, bisogna prima immaginarselo il proprio futuro per sperare che prima o poi si realizzi. E se tanti immaginano la stessa cosa, alla fine potrebbe anche succedere.
Peccato che la sinistra abbia perso tanta, troppa della sua capacità utopica. Si è rannicchiata nella folk politics, la «politica dal basso» che anche il traduttore preferisce lasciare in inglese. Quella orizzontale, senza leader, che rischia gravemente di esaurirsi nel gesto atletico come è successo spesso dal ‘68 in poi e senz’altro in Occupy Wall Street e vari altri movimenti recenti, nella prospettiva di Srnicek e Williams. «Politica trasformata in passatempo, politica come una droga, ripetitiva e noiosa», la ridicolizzano, con buona pace del Pueblo unido jamas sera vencido e degli Inti Illimani suoi cantori. In realtà, e sempre gramscianamente, Occupy ha sdoganato in America parole tabù come «lotta di classe» e ha reso credibile la candidatura altrimenti impensabile del «socialista» Bernie Sanders.
Non sono troppo ingenerosi con gli ultimi mohicani che ancora scendono in piazza? Srnicek risponde via email: «La folk politics è assolutamente necessaria, non la rigettiamo affatto, ma purtroppo non è sufficiente. Ha bisogno di essere integrata da altre forme di azione politica, strumenti nuovi che possano generare un cambiamento sistematico».
Il capitolo sesto, che offre alcuni scenari per il mondo post lavoro, si apre con la seguente citazione: «L’obiettivo del futuro è la piena disoccupazione». Forse è vero ma il fatto che a firmarla sia Arthur C. Clarke, il celeberrimo autore di 2001 odissea nello spazio dice qualcosa sull’opera. Quando la piena automazione si sarà realizzata, infatti, ci sarà il fastidioso problemino di come portare il pane in tavola al «surplus di popolazione» di cui faremo tutti parte. La soluzione è individuata nel reddito universale, che gode di fan dalle destra libertaria americana ai centri sociali extra-parlamentari. Ma dove prendere i soldi? Il compito sarebbe «relativamente facile» (premio ottimismo 2018!): «Servirebbe cioè tagliare quei programmi alternativi che un reddito base renderebbe ridondanti, aumentare la tassazione sui ricchi, e poi imposte di successione, tasse sul consumo, carbon tax, taglio della spesa militare, taglio dei sussidi all’industria e all’agricoltura, e una stretta sull’evasione fiscale». Gli ostacoli veri, spiegano i nostri, non sono economici ma politici e culturali. Obbietto a Srnicek che il lavoro non è solo reddito, ma anche identità. Non ci sta: «Anche l’assunto che solo il lavoro stipendiato fornisca significato è problematico. C’è vita oltre al lavoro. Invece si sottoporci a un capo per 40 ore alla settimana potremmo passare le giornate a studiare filosofia, accudire la famiglia o coltivare il giardino. L’opposto di manodopera pagata non è pigrizia, ma piuttosto sovranità temporale, la capacità di scegliere ciò che vogliamo». Gli contesto anche che l’automazione, lungi dal dare potere ai lavoratori, renderebbe ancora più forte il capitale che le macchine possiede: «Non nascondiamo che queste tendenze decimeranno i lavoratori se non cominciamo a mobilitarci. Come scriviamo “la miseria è una scenario più verosimile del lusso”: nelle condizioni attuali saranno i capitalisti a beneficiare di queste trasformazioni tecnologiche, mentre tutti gli altri soffriranno. Il nostro libro non ha ottimismo sul futuro se le condizioni rimangono inalterate, ha ottimismo su come potrebbe essere cambiato». Sacrosanto. Se però è già difficile difendere i lavoratori dal tasso di automazione corrente, mi sembra ancora più arduo tutelarli da una robotizzazione accelerata.
Sia quel che sia, i due autori auspicano che i pochissimi lavori risparmiati dalla sostituzione tecnologica si svolgano a ritmi più umani, possibilmente nella formula della «settimana di tre giorni». Un’idea non nuova ma più realistica (in Germania hanno appena avviato la sperimentazione su settimane da 28 ore) rispetto allo scenario che ci vedrebbe, presto, pigramente sorseggiare a bordo piscina un frozen Margarita grazie al mensile versato dall’Inps.
DA VEDERE: CALIFORNIE
Un po' Ken Loach, senza coscienza di classe, ma con un volto indimenticabile. La recensione completa sulla newsletter del Venerdì (mentre Galapagos si occupa dell’acquisto di Twitter da parte di Elon Musk).
Epilogo
Con pochi o tanti giorni, salario grasso o magro, buon primo maggio a tutti!