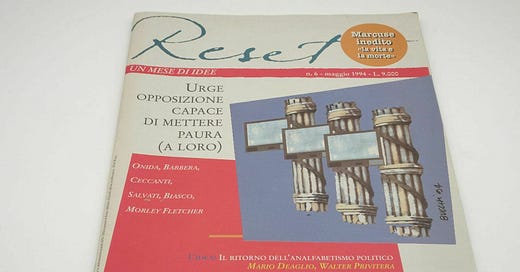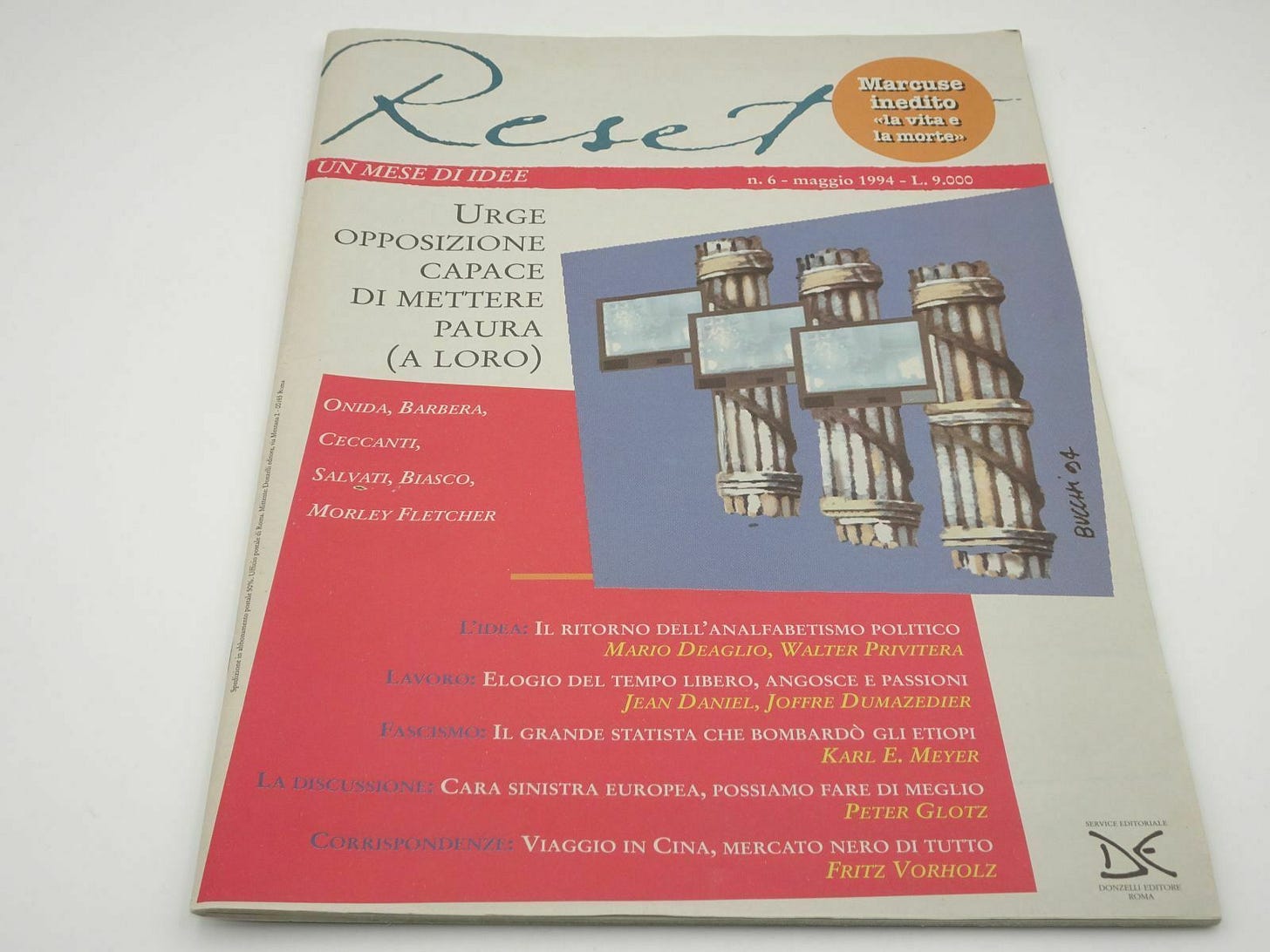#55 Il grande Reset (quello buono)
Che vita Amartya Sen!; Stiglitz: solo lo Stato può rispondere alle pandemie; i morti di disperazione di Deaton; masse e élite a Princeton; 1993, nasce una rivista di sinistra
ARTICOLI. LIBRI. VIDEO. PODCAST. LIVE. BIO.
Prologo
Sono stato molto fortunato. Appena uscito dalla scuola di giornalismo ho cominciato a scrivere per Reset, allora mensile, diretto da Giancarlo Bosetti e che aveva nel suo comitato scientifico, per dire, gente come Norberto Bobbio. Fortunato perché c’era Bosetti che mi passava i pezzi e mi insegnava tutto il resto e anche perché, grazie a una griglia grafica di prima pagina stupefacentemente democratica, poteva capitare, ancora ventenne, di firmare accanto a Jurgen Habermas. È in quel periodo che incrociai Amartya Sen in un convegno organizzato da Reset a Princeton. Una concentrazione di intelligenze così densa che, se avessero messo una bomba, avrebbero abbassato di colpo il Qi globale di vari punti. Formidabili quegli anni.
LA STRAORDINARIA AVVENTURA INTELLETTUALE DI SEN
Il passaggio decisivo, nella biografia accademica di Amartya Sen (Nobel per l’economia, 1988) , è quando arriva a Cambridge. Dove fa amicizia con i molti italiani che la frequentavano. Estratto dall’intervista sulla sua autobiografia La mia casa è il mondo (Mondadori) sul Venerdì in edicola:
Il cui circolo di cultori italiani è nell’ateneo inglese molto nutrito. A partire dal pisano Piero Sraffa, l’uomo che pagava libri e blocchi per gli appunti a Gramsci per scrivere dal carcere, poi direttore di studi di Sen che ne celebra l’indipendenza di pensiero («Quando Gramsci scrisse una critica di Bucharin Sraffa lo corresse dicendo che quella, in verità, era un’idea di Lenin e che era più facile criticare il primo che il secondo se non si voleva passare per controrivoluzionari»). E poi Luigi Pasinetti e Pierangelo Garegnani. A cui si aggiungeranno, sul fronte liberale, Luigi Spaventa e Beniamino Andreatta. Diverrà buon amico di tutti loro. Il rapporto col nostro Paese farà un salto di qualità quando si sposerà in seconde nozze con Eva Colorni, ex-moglie di Giorgio La Malfa nonché figliastra di Altiero Spinelli, tra i fondatori dell’idea di Europa unita («Eva era a Cambridge di passaggio. Ci incontrammo a un paio di feste. Avevamo molte cose in comune, una forte affinità»). È con lei che scoprirà l’hotel Le Dune di Sabaudia dove Giorgio Napolitano mandava un’auto del Quirinale a prenderlo per passare le serate a chiacchierare («Mi piace il suo modo di pensare e di vedere la storia»). Sempre a Roma, nei quattro mesi di studio che passerà ospite della Banca d’Italia, conoscerà Draghi («Ricordo ancora con piacere le nostre conversazioni») e Tomaso Padoa Schioppa.
E oggi, dopo aver visto e capito tanto, cosa lo preoccupa? «Il fatto che il mondo sia ancora un luogo pieno di ostilità. Penso a Russia e Ucraina ma anche alla Brexit, di cui ancora non mi capacito (spira un brutto vento anti-Ventotene che avrebbe amareggiato il mio ex-suocero). O al Brasile, che dopo tanti progressi su istruzione e sanità è finito alla visione ristretta di Bolsonaro. E, ovviamente, alla mia India e alla violenza settaria di induisti contro musulmani. Ci sono così tante, evidenti ragioni per integrare le culture e vivere in pace, eppure…». Il laicissimo Sen sa che la religione spesso non aiuta e per questo apprezza il razionalismo di Buddha, il suo sapersi concentrare sulle ragioni che portano ad accettare una posizione e rifiutarne un’altra («È passato dalla domanda “Esiste un Dio?” a quella “In quale modo dobbiamo comportarci?”, indipendentemente dal fatto che un Dio esista oppure no»).
STIGLITZ: SOLO LO STATO CI PROTEGGE
Poco prima della chiusura del mondo causa primo lockdown ero andato a New York per intervistare Joseph Stiglitz (Nobel per l’economia, 2001) sul suo Popolo, potere, profitti (Einaudi). Un estratto:
Tra le altre pessime cose, il coronavirus può essere letto anche come parabola avvelenata della globalizzazione?
«Senz’altro. Intanto perché i virus, come il riscaldamento globale, non hanno bisogno di passaporto per fare il giro del mondo. Sono globali per definizione. E poi perché eventi come questi confermano l’assunto principale del mio libro. Ovvero: quando la gente ha bisogno di essere protetta da rischi seri, si rivolge allo Stato, non certo ai privati».
Per poi scoprire che Donald Trump ha ridotto dell’80 per cento il budget dei Centres for disease control che dovrebbero fronteggiare l’emergenza…
«Esattamente nel capitolo sulla prevenzione di epidemie globali. Ci voleva della geniale preveggenza per intaccare proprio quella spesa, e lui l’ha avuta. Aggiungo che questa vicenda fa risaltare anche i rischi di una presidenza mai così profondamente antiscientifica, basti pensare alla negazione del climate change. Mentre qui l’unica cosa che ci può salvare è la scienza e i fondi pubblici di cui ha bisogno».
La Banca centrale americana ha tagliato i tassi, ma non sembra essere bastato. Quali conseguenze prevede per l’economia mondiale?
«È difficile dire. Lo scenario peggiore è quello con il 30-70 per cento della popolazione contagiata e con un tasso di mortalità dell’1-3 per cento. Significherebbe, nelle ipotesi migliori, 2 miliardi e rotti di contagiati e oltre venti milioni di morti. Ciò che si vede già, invece, è la rottura della catena dell’offerta di merci e anche di quella della domanda, in un’economia sempre più interconnessa che non può fare a meno della Cina. Se uno, come fa Trump, equipara il benessere dell’economia con quello della Borsa, allora si illude che la politica monetaria possa bastare, ma per la gente normale non è così. E se uno ha deciso di chiudere la fabbrica perché non ha più fornitori, non è che cambia idea per i tagli dei tassi».
Siete messi meglio o peggio del resto del mondo, quanto a capacità di reazione?
«Purtroppo peggio. Qui milioni di persone non hanno reti di salvataggio. Se un cameriere è malato e non può restare a casa perché altrimenti non guadagna, moltiplicherà il contagio. Idem per molte persone che non faranno i test per paura di doverli pagare o di far aumentare il premio assicurativo».
I MORTI DI DISPERAZIONE DI DEATON
Un paio di anni fa ho intervistato Angus Deaton (Nobel per l’economia, 2015) e la moglie Anne Case sulla versione italiana del loro Morti per disperazione e il futuro del capitalismo (il Mulino). Un estratto:
Succede in America che, a un certo punto, uomini nel pieno della maturità abbiano cominciato a cadere come mosche. Suicidi, overdose, cirrosi. Ma la notizia, più che i brutti decessi, è che riguardassero la più privilegiata categoria di cittadini: i bianchi, tra i 45 e 54 anni. La loro aspettativa di vita, durante il ventesimo secolo, era schizzata da 49 a 77 anni. Poi, a cavallo del 2000, qualcosa si era rotto, ma cosa? Su questo interrogativo Anne Case e suo marito, il Nobel per l’economia Angus Deaton, hanno costruito Morti per disperazione e il futuro del capitalismo (il Mulino), il poderoso tentativo di due economisti di Princeton di venire a patti con uno smottamento che interpella molte altre scienze sociali. Libro importante, anche se impegnativo, che aggiunge l’ennesima pietra nel grande edificio teorico degli studi sulla disuguaglianza.
Caratteristica in comune di questi morti per disperazione è l’assenza di laurea: è il miglior elemento predittivo di crepare anzitempo?
AD: «Non si può sapere, ma è quello che avevamo a disposizione dai certificati di morte che non dicono che lavoro facevano i deceduti, quanti soldi avevano (anche se negli ultimi 40 anni il potere d’acquisto dei bianchi non laureati è sceso del 13 per cento, contro un aumento del salario nazionale dell’85) e tante altre cose sul loro conto. Però l’aumento della mortalità ha riguardato perlopiù gente non laureata».
Chiariamo subito una cosa: l’eccezionalità sta nel fatto che la mortalità dei bianchi sia cresciuta mentre quella dei neri (doppia ancora nei primi anni ‘90), diminuiva, no?
«Certo. Tra l’altro impennate simili di mortalità erano già accadute tra i neri negli anni 80. È come se le stesse disfuzioni sociali (meno matrimoni, figli nati fuori dal matrimonio, mancanza di senso di comunità) si ripetessero oggi per i bianchi con bassa istruzione. L’abuso di farmaci oppioidi ha avuto un grosso ruolo tra le morti per disperazione dei bianchi e si è diffusa tra gli afroamericani solo dopo il 2013».
MASSE E ÉLITE, RESET A PRINCETON
La cronaca del convegno di Reset a Princeton, uscita il 10 novembre 1996 sull’Unità.
PRINCETON. Alle radici del risentimento sta un apparente paradosso. Lo svela Michael Walzer: «Le vittorie politiche liberali, sul terreno sociale e civile, sull’aborto, sulle minoranze, sull’abolizione della censura, hanno avuto un contraccolpo in termini di populismo. È questa una delle principali ragioni della svolta a destra della politica americana». È evidente che qui il noto filosofo americano si riferisce ad una svolta culturale, a qualcosa di più profondo del semplice risultato elettorale. Quei passi avanti della cultura liberal nei diritti civili, decretati dalle decisioni delle Corti, non avevano alle spalle delle connessioni materiali, un movimento politico: «Se provassimo a mettere insieme le connessioni materiali che vi stanno alla base, le donne che abortiscono, i marginali, i gay, potremmo farne risultare una coalizione politica? No: dobbiamo affrontare frontalmente questa sconnessione e impegnarci nella trasmissione della cultura di sinistra tra le nuove generazioni. Altrimenti non avremo più alcun credito». Assieme a lui filosofi, sociologi e professori di scienze sociali hanno valutato lo stato di salute della politica, misurandone un indicatore eloquente: il rapporto tra masse ed élites. Da qui il titolo del convegno organizzato dal mensile «Reset» assieme al «Committee for european studies» della Princeton University: Democracy between Populism and Oligarchy. Ne è risultato un aumento dell’«antipolitica» e di una graduale metamorfosi dei format tradizionali delle principali categorie politiche, complici la globalizzazione, la crisi dei bilanci statali, la protesta fiscale che spingono la sinistra «a rivedere la linea storica di espansione della spesa sociale, facendo sue alcune delle richieste tradizionali della destra». Sul campo di gioco politico le formazioni avversarie non hanno più le maglie ben distinguibili dei sostenitori del libero mercato contro i fan del Welfare system e così, negli Stati Uniti, si può ascoltare il feroce Pat Buchanan affermare, senza ombra di rossore sulle sue guance, che «se c’è un ruolo per il partito repubblicano, è quello di difensore della classe lavoratrice» come racconta, con umorismo amaro, Michael Kazin autore di The populist persuasion. D’altronde se, con Nadia Urbinati, «l’aumento del populismo è collegato con la povertà economica e sociale» paradossi del genere si verificheranno ancora, lungo la strada ripida e faticosa che porta in Europa: «La durezza finanziaria imposta dagli ingegneri di Maastricht hanno avuto un ruolo predominante nel dare forza al partito della libertà di Jörg Haider, l’Alleanza nazionale di Gianfranco Fini, il Fronte nazionale di Le Pen e i Republikaner tedeschi». Ma perché la sinistra si interroga oggi su questa distanza tra il sotto e il sopra della società? «Una tale frattura - spiega Gianni Vattimo - non è una novità, c’è sempre stata e forse è diventata visibile proprio nelle democrazie formali dove le masse, con tutti i limiti che conosciamo, hanno potuto prendere la parola». Piuttosto le difficoltà derivano dal fatto che «la sinistra è sempre stata storicamente volontà di cambiare l’esistente, perché esprime i bisogni e le aspirazioni dei meno favoriti, dei ceti deboli. Ha perciò bisogno, più della destra conservatrice e “realista’’, di un progetto di società che si legittimi in base a ragioni teoriche, e non in riferimento al corso “normale” delle cose». Le masse spesso, nel mondo industriale avanzato, non scelgono la verità perché l’opinione pubblica sarebbe manipolata. Berlusconi - si diceva - vince perché sa usare le televisioni, perché è la televisione: ricordate? Beh, ancorché superficiale, l’argomento ha una sua validità secondo Vattimo: «La sinistra concepisce e pratica ancora il dibattito politico in termini che non si lasciano tradurre facilmente nello spettacolo televisivo (l’Unità è forse l’ultimo giornale che in Italia ha mantenuto la tradizione della terza pagina); per le stesse ragioni, del resto, gli intellettuali sono in maggioranza orientati a sinistra, in tutti o quasi i paesi di democrazia industriale avanzata (in Usa intellectual e liberal sono sinonimi)». Ed è proprio attraverso i nuovi media che il populismo si declina in chiave elettronica, creando soltanto l’illusione di un rapporto tra masse ed élites. Un artificio dal quale Jürgen Habermas faceva derivare una duplice conseguenza: quelli che sanno dominare le nuove tecnologie, le nuove élites, saranno attori della nuova società, per loro varrà la meritocrazia, la competizione; per tutti gli altri, per il gran circo delle masse, il ruolo designato è quello indicato da un’altra parola: di passiva audience.
RESET: LA SINISTRA SCOPRE IL FASCINO DELLA NORMALITÀ
Alla fine del ‘93, l’Ifg di Milano mi mandò a seguire, al Circolo della stampa, la conferenza stampa di presentazione di Reset. Avevo 25 anni. E la scuola scoraggiava l’originalità. Abbiate pietà.
«Per una Sinistra normale, priva di complessi di appartenenza, priva di elementi di rissosità. Non siamo né depressi per quello che è successo dall’89 in avanti né contenti o carrieristi.....il nostro principale problema è di lavorare perché la Sinistra disponga di un’opinione pubblica la più aperta possibile». Così Giancarlo Bosetti - attuale vicedirettore dell’Unità - giustifica la nascita di Reset (Donzelli editore, £ 9000), il nuovo mensile che dirige. A mezza strada tra la cronaca sociale e il saggio, gli articoli sono corti, ma densi, incastonati in rubriche costanti. La scommessa è quella di contrastare la volgarità che dilaga nel linguaggio dei mass-media.
Trentuno soci fondatori, tutti intellettuali di vaglia - da Norberto Bobbio a Salvatore Veca - che si possono ricomprendere nella sempre più generica dizione di “Sinistra” a patto di accordarle veramente -come fa, tra loro, Giovanna Zincone - una struttura “a cipolla”, metafora della composita stratificazione dei partiti che oggi si dicono di progresso. Persone che hanno investito in proprio, sottoscrivendo 5 milioni ciascuno (salvo il maggior impegno dell’editore Donzelli e di Francesco Micheli, di Finarte), garantendosi in questo modo la facoltà di nominare e revocare il direttore a maggioranza.
Reset, termine inglese: come dire “azzerare, ricominciare da capo”. Ma non c’è traccia di pentitismo nelle parole dei collaboratori rispetto alle idee. Piuttosto si prendono le distanze dall’attitudine di una certa intelligentsia della Sinistra tradizionale: l’ inadeguatezza a pensare in termini di governo. Un titolo che molti dei soci hanno contestato. Anche Bobbio: in piemontese il titolo suona come “ricette”.
Durante la presentazione milanese una signora dal pubblico lancia una provocazione: “Cosa ci fa la pubblicità del Gruppo Fininvest a tutta pagina nel bel mezzo del giornale?” Nessuno si scompone, e il direttore, sereno, auspica pubblicità di tutti i tipi per sostenere le magre finanze del periodico. Se per qualche “purista” tale affermazione può suonare cinica - la resa al mercato -, molti apprezzano la fine di un integralismo.
Epilogo
Grazie Giancarlo!