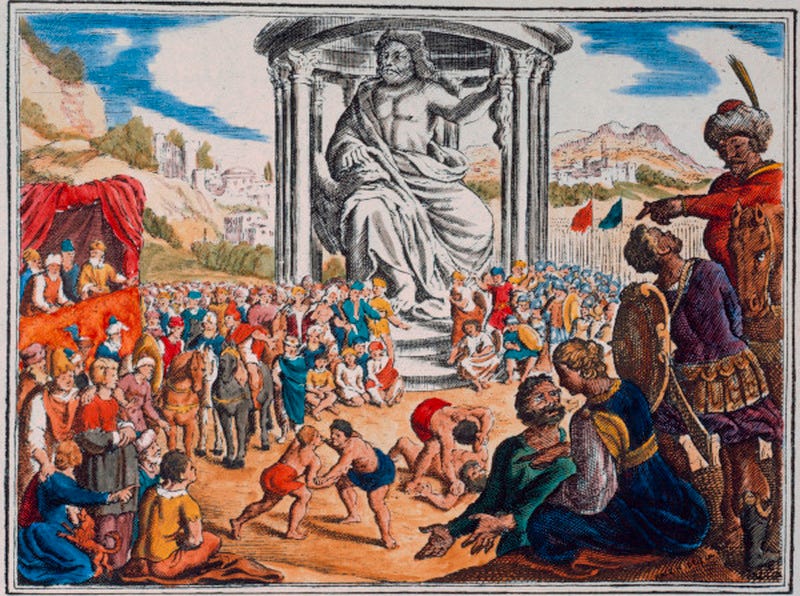#29 Le Olimpiadi, maledizione...
Manchester, regina del calcio; le gambe islandesi di Pistorius; a Tokyo sulle tracce di Lost in translation; Juan Villoro, talento per intenditori; Considera l'aragosta; Marx può aspettare
ARTICOLI. VIDEO. PODCAST. LIBRI. LIVE. BIO.Prologo
Impazzano le Olimpiadi e non ho niente da dire. Mi era sembrata meravigliosa la storia del lanciatore del peso africano che aveva fatto perdere le sue tracce a Tokyo, lasciando un messaggino alla moglie. Quanto poteva durare la sua fuga in uno dei Paesi etnicamente più omogenei al mondo? Come un gatto in tangenziale, e infatti l’han beccato su un trenino mentre cercava di andare non so bene dove. Che fine farà di ritorno in patria? Non lasciamolo solo. Si lanciano tante petizioni non proprio cruciali: non dimentichiamoci neppure di lui.
MANCHESTER, EPICENTRO DEL CALCIO GLOBALE
A memoria mia ho scritto espressamente di sport un’unica volta in vita mia. Me l’ha chiesto Aligi, un po’ come provocazione, non appena è arrivato a dirigere il Venerdì. Voleva uno “sguardo non tecnico”, aveva detto. Il pezzo – pietà – iniziava così:
Manchester. In fila per entrare nel «teatro dei sogni», come lo chiamano da queste parti, ci saranno cinquanta ragazzi cinesi. L’Old Trafford, leggendario stadio dello United, è la Cappella Sistina di Manchester, solo con un biglietto più caro (21 euro contro 16). I quattro ragazzi vietnamiti che fanno il tour con me hanno anche abboccato all’offerta dell’istantanea sullo sfondo fotografico degli spalti pieni (10 sterline) e il pachistano che supplica la guida di immortalarlo a ogni tappa del giro, soprattutto nello spogliatoio accanto alla maglietta del nuovo acquisto Ibrahimovic, non vede l’ora che la visita sfoci nel megastore dove comprarsela una tutta per sé, alla modica cifra di 75 pound. Sì, è volgare mettere l’etichetta del prezzo su un immaginario. Però è anche difficile ignorare questa inesorabile macchina da soldi. Perché sono questi che hanno trasformato la rivale, il brutto anatroccolo del City, nel secondo cigno calcistico della città. Senza i petrodollari degli emirati, Pep Guardiola non sarebbe venuto qui a rinnovare la sfida con José Mourinho e la città non sarebbe divenuta la capitale del calcio mondiale. «È stato come quando Peter Parker viene morsicato dal ragno radioattivo e diventa Spider Man» dice David Winner, autore di Those Feet: An Intimate History of English Football, «d’improvviso il City ha sviluppato superpoteri. Era già successo con il Chelsea sotto Abramovich. E al Paris Saint-Germain con gli investimenti qatarioti». Eravamo venuti a cercare le presunte due anime della città, quella rossa e blu delle magliette del derby che da locale è diventato planetario, abbiamo dovuto ripiegare sul potere trasformativo del denaro. D’altronde è qui che Friedrich Engels scrisse le prime cronache sulla condizione operaia a partire dalle quali Karl Marx sviluppò il concetto di plusvalore, motore del capitalismo. E quelle filigrane esagonali che si intravedono sulle magliette dello United stilizzano un alveare, le api operose che dalla prima rivoluzione industriale sono il simbolo proletario della città oggi epicentro della massima plutocrazia sportiva.
SULLE TRACCE DELLE GAMBE DI PISTORIUS
L’unica altra volta che il pretesto era stato, lato sensu, sportivo era alla fine del 2007 quando ero andato in Islanda per raccontare la fabbrica che produceva le gambe artificiali usate anche da Pistorius.
REYKJAVIK. Ingegneristicamente parlando, camminare è tutto meno che una passeggiata. Non ci si pensa mai perché è naturale, a stento si ricorda quando si è appreso a farlo. Ma basta vedere un amputato per capire di colpo che inferno di complessità meccanica sia il più banale dei movimenti. Se si punta alla fluidità, a evi- tare l’effetto scarponi da sci, è un esercizio nient’affatto pedestre. Nessuno lo sa bene come quelli della Ossur. È da qui, dal quartier generale nella bruma ghiacciata di Reykjavik, che sono uscite le lame di fibra di carbonio che hanno fatto correre al bi-amputato Oscar Pistorius i 400 metri in 47”34. E sempre in questi laboratori, l’anima divisa in due tra i trucioli d’acciaio di un tornio industriale e la perfezione sottovuoto di Los Alamos, si sono inventati la prima gamba bionica. Quella che, grazie all’intelligenza artificiale di un computer lillipuziano, mima il comportamento di una gamba sana, tutta muscoli e ossa.
L’anno appena finito è stato il più sfavillante nella storia dell’azienda. Da quel 1971, quando Ossur Kristinsson, una deformazione congenita al piede sinistro, la fondò per migliorare la vita dei mutilati come lui. Iniziò con l’introdurre dei rivestimenti di morbido silicone al posto della stoffa che proteggeva il moncherino su cui montare la protesi. Una rivoluzione da poco, ma un bestseller che regge nel 2007 dei record per l’azienda.
A TOKYO CERCANDO L’ALBERGO DI LOST IN TRANSLATION
Quanto al Giappone, che le Olimpiadi le ospita, è l’unico Paese al mondo dove ho pensato: neanche se mi pagassero tanto vorrei vivere qui. Tutto mi sembrava così inintelligibile, alieno, troppo diverso da noi che starci non avrebbep potuto essere altro che un lungo esercizio di autismo. La seconda volta che l’ho visitato approfittai per mettermi sulle tracce dell’hotel Hyatt dove avevano da poco girato Lost in Translation. Un pezzo così antico che ve lo ripropongo tutto:
TOKYO. È la capitale delle traduzioni impossibili. E quindi Tokyo è anche l'inevitabile location del formidabile film di Sofia Coppola, Lost in Translation, che il 5 dicembre arriva nei cinema italiani con un titolo, L'amore tradotto, che non rende quanto l'originale: Perso nella traduzione, appunto. Roppongi, tanto per cominciare, è il quartiere di quelli che i giapponesi chiamano gentlemen club, e invece sono posti dove, a giudicare dalle giarrettiere nelle locandine (e al molto che non coprono) un gentiluomo non metterebbe mai piede. Dal suo incrocio principale, se chiedete dell'Hotel Hyatt a tre, quattro passanti, nessuno vi risponde in inglese ma tutti vi mettono sulla strada a gesti e sorrisi: tutto dritto, si capisce, e ci si inchina per contraccambiare. Ora, l'Hotel Hyatt è la location del secondo film (dopo il bell'exploit del Giardino delle Vergini suicide) della figlia di Francis Ford, che ha conquistato l'ultima Mostra del Cinema e in America è già cult. Ma quando finalmente si arriva alla Mori Tower, il certificato edile di onnipotenza della ricchissima famiglia di imprenditori, e la segnaletica a fumetti disegnata dal celebratissimo Takeshi Murakami indica "Grand Hyatt", è solo la prima di una lunga serie di malintesi quella di credere di essere arrivati a destinazione. "Scusate, dov'è il posto in cui il film di Sofia Coppola è stato girato?". Tutto il personale è vestito Armani, o qualcuno che gli assomiglia sfacciatamente. Ma nonostante il completo di taglio occidentale il ragazzo strabuzza gli occhi: "Film qui? Nessun film qui" e prende una cartina del quartiere per mostrare dove sono le sale più vicine. Se provate a insistere sullo "shot", "girato", il giovane chiama un superiore, che non ne sa niente. L'imbarazzo cresce, palpabile, sulle loro facce. Hai voglia a spiegare che il luogo dove si incontrano i due protagonisti, Bob (Bill Murray) e Charlotte (Scarlett Johansson), è un american bar dalle cui immense vetrate si vede tutta la città... Finalmente il caposala, un inglese, svela l'arcano: "Il posto che cerca è al Park Hyatt: 20 minuti da qui". Scendendo al decimo piano, ecco una sala da dove entra e esce un sacco di gente. Un cameriere chiede: "Serve aiuto?". "Sì, saprebbe indicare il posto dove hanno girato il film...". Film? Quale film? Questa è la sala dei matrimoni, festeggiati con tanto di karaoke e, certo, "qui tutti filmano film", sono i filmini, tutti girati con le videocamere digitali (ce ne sono almeno una ventina in funzione contemporaneamente) e anche il cameriere mima il gesto della cinepresa... E torna subito in mente la scena del film in cui Bob - un attore che negli Usa ha già iniziato la discesa - resta sgomento quando il regista giapponese dello spot che deve girare a Tokyo cerca di spiegargli l'espressione giusta da assumere per pubblicizzare una marca di whisky: l'uomo mitraglia un migliaio di parole che al termine l'interprete sintetizza con un "più intenso", l'attore sembra basito ma i due milioni di dollari di compenso gli danno una riserva inesauribile di pazienza e decide che l'unico modo è di fare come gli viene: "For relaxing times, it's Suntory time", sentenzia infine sornione, e all'interlocutore non resta che arrendersi alla sua interpretazione. Il resto di Lost in Translation si svolge perlopiù dentro i sessanta e passa piani dello spazio ermetico dell'Hyatt. Charlotte è la 25enne moglie di un fotografo di moda che ha a fuoco tutto meno che le ansie crescenti della ragazza. Lui è fuori tutto il giorno, lei guarda la città dalle finestre della camera. Spesso piange e quasi mai riesce a prender sonno. Come il cinquantacinquenne Bob, che ha la faccia di uno che ha digerito un sacco di bocconi amari nella vita ma non riesce a buttar giù il jet lag e vaga tra il bar e i corridoi di quell'enorme stazione spaziale. I due si vedono e si sorridono, cominciano a cercarsi per farsi compagnia. Lui intanto riceve nel cuore della notte i fax della moglie che calcola male i fusi orari e lo mette al corrente delle opzioni possibili per la moquette: "Meglio color prugna o amaranto?". Non sa cosa rispondere, non gli sembra che faccia (più) una gran differenza e le telefonate intercontinentali con la compagna di una vita sono burocratici, sonnolenti, penosi scambi di monosillabi intervallati da silenzi che il ritardo della comunicazione acuisce. Marito e moglie parlano la stessa lingua ma non si capiscono più. E a diecimila chilometri da casa Bob, lentamente, impercettibilmente, entra in contatto con l'altra giovane ospite alienata di quell'albergo cinque stelle. Un avvicinamento costellato di trovate geniali e spassose. Come quella dell'attempata geisha che mandano in camera all'ex stella hollywoodiana e che vuole farlo felice al grido di "strappami le calze" ("rip my stockings") che, malpronunciato; si trasforma nell'ancora più grottesco "lick my stockings", "lecca le mie calze". Lost in Translation: perso nella traduzione... Le celle extra-lusso dell'Hyatt - che uno zelante capo ora mostra con orgoglio nipponico - sono l'ideale contenitore sottovuoto delle rispettive solitudini. Anche la scenografica piscina del 45esimo piano, dalle cui finestre a vetri si vede la metropoli con le sue lucine distanti, è illuminata da faretti che rendono il suo azzurro non tanto di acqua ma di amnio, in cui i due naufraghi ritrovano un surrogato di natura. "Non succede molto", sintetizza David Denby sul New Yorker, "ma il film crea un incantesimo". "Uno dei più bei film dell'anno", dice il critico del San Francisco Chronicle. "La relazione tra Bob e Charlotte", scrive Salon, "è un momento di intima magnificenza. Mai visto niente del genere". E così è, un amore impossibile, agrodolce e intraducibile, che nasce e si compie nell'empireo terrestre e tutt'attorno nuvoloso del Park Hyatt.
LA MIGLIORE INTRODUZIONE AL GIAPPONE…
L’ha scritta il messicano Juan Villoro. Qui c’è una versione in spagnolo (che Internazionale aveva tradotto nel 2010 ma non ne trovo traccia). È un talento assoluto, dovreste leggere tutto quel che scrive e per convincervi vi lascio qui un pezzo dell’intervista che gli avevo fatto nella campagna fiorentina qualche anno fa:
Villoro è il corrispettivo letterario di quelle spiagge superbe e poco frequentate che ti inorgoglisce conoscere solo tu, sapendo che non potrà durare e presto saranno invase da legioni vocianti. È tradotto da meritorie case editrici come Sur, Ponte alle Grazie, Gran Vía, Titivillus, Cuec, ma resta sbalorditivo come non abbia ancora conosciuto da noi il successo di massa che merita. Laureato in sociologia, figlio di un importante filosofo, docente di scrittura a Yale, Princeton e prossimamente a Stanford, ha una gravitas accademica che stempera nell’ironia. Come quando, in C’è vita sulla terra?, si interroga, tra le altre cose, sulle dinamiche tra esseri umani in zona ammazza-caffè («La gastrosofia non ha studiato a sufficienza questa zona blanda delle relazioni sociali, la pausa in cui qualcuno deve giustificare perché si trova a tavola»). Gli chiedo perché i latinoamericani sembrano, oggi, i più bravi e vitali di tutti. «La ringrazio e non sta a me dire se sia davvero così. Di certo la realtà di molti dei nostri Paesi è abbastanza complessa e trasforma il semplice vivere lì in uno sport estremo. Aggiungo che, con una tradizione meno consolidata di quella anglosassone, ci consentiamo un margine di libertà maggiore». Quanto ai criteri cui si ispira, aderisce alla lezione di Nabokov per cui la letteratura funziona quando ti dà un brivido lungo la schiena. «Scrivere, per me, è razionalizzare questo brivido. E parlarne con gli studenti è una maniera per provare a chiarirlo a me stesso». Il suo pantheon di promesse letterarie, spesso già abbondantemente mantenute, è un gineceo: Leila Guerriero, Guadalupe Nettel, Samatha Schweblin, Mariana Enriquez, Valeria Luiselli, Lina Meruane. Di alcune abbiamo già sentito parlare (per tacere della capostipite, la poetessa Silvina Ocampo), delle altre è utile prendere nota. Tra gli uomini ricorda giusto Alan Pauls che ha dimostrato del fegato arrampicandosi per la millesima volta, ma a quanto pare aprendo percorsi nuovi, sul monumento di Borges.
DA LEGGERE: CONSIDERA L’ARAGOSTA
Non c’entra specificamente con lo sport, ma c’entra in tutto e, per quanto mi riguarda, si potrebbe tenere un corso di giornalismo (ci sto lavorando) solo glossando questo libro fenomenale. Di cui vi propongo solo un pezzo del saggio del 2001 dal titolo Come Tracy Austin mi ha spezzato il cuore.
Essendo un fan sfegatato del tennis in generale e di Tracy Austin in particolare, di rado mi è capitato di attendere un’autobiografia sportiva con l’impazienza con cui ho atteso Beyond Center Court: My Story di Tracy Austin, scritto in realtà da Christine Brennan e pubblicato da Morrow. È uno di quei libri per il grande pubblico–l’autobiografia di un campione-«con»-qualcuno–di cui a quanto pare ne ho comprati e letti a bizzeffe, provando tutta una serie di alti e bassi, ambivalenze e imbarazzi, di solito mettendoli sotto qualcosa di più intellettuale quando vado alla cassa. Penso però che forse l’autobiografia di Austin abbia definitivamente estinto la mia passione per il genere. Ecco la Austin di Beyond Center Court sul primo set della finale contro Chris Evert agli US Open del 1979: «A 2-3, ho fatto un break a Chris, poi lei l’ha fatto a me, poi io l’ho fatto di nuovo a lei, quindi eravamo 4-4». E sull’epifania dopo aver vinto quella finale: «Capii subito cosa avevo fatto, cioè vincere gli US Open, e mi sentii elettrizzata». Tracy Austin sui rigori psicologici della competizione agonistica: «Ogni atleta professionista dev’essere così affinato mentalmente». Tracy Austin sui suoi genitori: «Mia madre e mio padre non mi hanno mai, mai spinta». Tracy Austin su Martina Navratilova: «È una persona meravigliosa, molto sensibile e altruista». Su Billie Jean King: «Anche lei è incantevole e incredibilmente accomodante». Su Brooke Shields: «Era così dolce e intelligente ed è stato facile parlarle fin da subito». Tracy Austin riflette sull’eccellenza: «È quel pizzico in più che alcuni di noi sono disposti a dare e altri no. Perché? Credo sia la sfida a essere i migliori». Vi siete fatti l’idea. A suo favore, però, bisogna dire che questa autobiografia, così insipida da lasciare a bocca aperta, può forse aiutarci a comprendere tanto la seduzione quanto la delusione che sembrano essere insite in un memoir sportivo di ampia divulgazione. Quasi tutti poveri come libri, questi «La mia storia» atletici vendono incredibilmente bene; è per questo che ce ne sono tanti. E vendono così bene perché le storie degli atleti paiono promettere qualcosa di più della solita autobiografia della persona celebre fitta di nomi famosi. Ecco una teoria. I grandi atleti sono affascinanti perché incarnano il successo basato sul confronto che noi americani veneriamo–il più veloce, il più forte–e perché lo fanno in modo non ambiguo. La questione di chi sia il miglior idraulico o il miglior ragioniere è impossibile persino da definire, laddove chi sia il miglior lanciatore, il miglior cestista o tennista è, in qualsiasi momento, una questione di record statistici pubblici. I grandi atleti ci affascinano perché fanno presa sulle nostre ossessioni gemelle per superiorità competitiva e numeri. Poi sono belli: Jordan sospeso a mezz’aria come una sposa di Chagall, Sampras che assesta una volée a un’angolatura che sfida Euclide. E ci ispirano. Negli atleti di livello mondiale che si affrancano dalle leggi della fisica c’è una bellezza trascendente che rende manifesto Dio nell’uomo. Quindi in realtà sono più teorie. I grandi atleti sono la profondità in movimento. Consentono ad astrazioni come potenza e grazia e controllo non solo di incarnarsi ma di essere teletrasmesse.
DA VEDERE: MARX PUÒ ASPETTARE
Non sono un gran fan del Bellocchio psicanalitico (si può senz’altro pronunciare un’eresia del genere in un Paese dove si infamano i vaccini) ma questo documentario sulla breve vita di suo fratello gemello Camillo è bellissimo. Che famiglia, questi Bellocchio! Quanta intelligenza in così poche persone. Viene da pensare che se avessero bombardato casa loro, dio non voglia, in un colpo solo avrebbero considerevolmente abbassato l’IQ di un’intera regione. Il titolo lo capirete vedendolo ed è, in sé, una magnifica lezione.
DA SENTIRE: UN’IDEA
La libera associazione è con la risposta che Camillo Bellocchio dà a Marco quando gli suggerisce di impegnarsi di più nella lotta di classe.
Epilogo
Dall’ultima Galapagos:
È la sindrome di Moby Dick: ogni Big Tech che si rispetti ha un suo Achab pronto ad arrivare fino in fondo per arpionarla. Facebook ha Max Schrems, attivista austriaco che da anni la denuncia per sistematiche violazioni della privacy. Tesla ha Aaron Greenspan che ne ha una denunciato alla Sec le pratiche finanziarie. Apple sin qui era stata risparmiata. Ancora circonfusa dell'aura di Steve Jobs e di una leggenda di diversità rispetto alla concorrenza, era considerata l'eccezione etica (vedi questo reportage sui pentiti della Silicon Valley) in una banda di farabutti. Non più. Il vendicatore si chiama Horacio Gutierrez e, con quei testacoda biografici cui l'America ci ha abituati, prima di accusare Cupertino di pratiche monopolistiche, difendeva Microsoft da accuse analoghe.
Il resto qui. Buon fine settimana più caldo dell’evo moderno, a quanto pare!