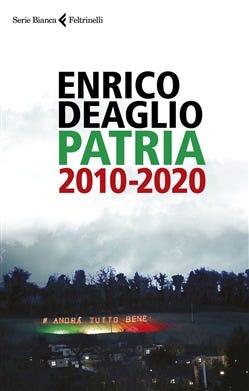#22 Le vite dei neri contano
La breve vita di Moussa Baldé; le vittime dimenticate di Traini; Luigi Manconi su Macerata; il Far West di Castel Volturno; Corcolle e le proteste anti-immigrati; Patria di Deaglio; Gloria Mundi; etc
ARTICOLI. VIDEO. PODCAST. LIBRI. LIVE. BIO.Prologo
Sui treni regionali che vanno verso le grandi città si incontra sempre più spesso un nuovo tipo di cliente, con bici e borsa termica al seguito. Nuovi fanti dell’esercito dei rider che consegnano nelle nostre case tutto il consegnabile. Esercito in crescita dal momento che ci sono da mantenere promesse sempre più stringenti: da un giorno, a due ore, a mezz’ora. C’è ormai chi promette di farti avere uno snack a domicilio entro dieci minuti. Dell’instant delivery si occupa l’ultima Galapagos (ma linko anche la newsletter del Venerdì che oggi compie un anno). A fare funzionare questa formidabile macchina logistica andranno soprattutto molti giovani e molti immigrati. La battaglia per i diritti di chi farà funzionare una vita a metro zero (dal nostro divano) è solo agli inizi.
MOUSSA BALDÉ, DUE VOLTE VITTIMA
Mamadou Moussa Baldé viene aggredito a mazzate da tre italiani a Ventimiglia (uno di loro dice per un tentato furto di telefonino, lui nega). Lo portano all’ospedale e gli danno una prognosi di dieci giorni ma soprattutto scoprono che non ha i documenti in regola. Così l’indomani lo trasferiscono, ancora intontito, al Centro di permanenza per i rimpatri (Cpr) di Torino dove dovrà aspettare l’espulsione nel suo paese, la Guinea. Non farà in tempo a vederla perché, incredulo del perché lui sia in gabbia mentre i suoi aggressori restino a piede libero, si impiccherà nella cella di isolamento dove l’avevano incomprensibilmente messo. Abbiamo provato a raccontarne la storia. Di seguito un estratto, in attesa della pubblicazione sul sito del Venerdì:
Finisce nel Cpr di corso Brunelleschi che è decisamente peggio di un carcere. «In prigione almeno» osserva Maurizio Veglio, legale esperto di diritto dei migranti, «sai quanto dura la pena e quali sono i tuoi diritti». Qui no. Tra le poche cose certe c’è la durata massima della permanenza (90 giorni, rispetto ai 180 dei decreti sicurezza Salvini). Il fatto che ti toglieranno il cellulare, dandoti in cambio una scheda telefonica da 5 euro che serve giusto per dire «sono vivo» se chiami in Africa. E il fatto che si sta così male che il 2011, l’ultimo anno in cui hanno tenuto il conto, ha fatto totalizzare 156 casi di autolesionismo, di cui 100 casi di ingoiamento di oggetti e 56 di tagli. D’altronde, osserva l’avvocato Veglio, «se ti fai molto male puoi sperare di essere ritenuto incompatibile con il Cpr, ma anche se ti fai poco male puoi comunque uscire per essere portato dal medico e sperare di fuggire». In entrambi i casi ti aprono le porte della cella. Un’altra delle poche certezze è che la riduzione delle risorse d’epoca leghista ha portato i medici nella struttura da una copertura di 24 ore a una di 5 ore al giorno. «Per i 107 trattenuti attuali» calcola la garante dei detenuti di Torino Monica Gallo «è veramente poca cosa perché la maggior parte di queste persone ha qualche vulnerabilità». Nel caso di Moussa, bastonato il giorno prima, non dovevano essere particolarmente difficili da notare eppure è stato valutato «idoneo» alla permanenza «in comunità ristrette». Un certificato verosimilmente riempito in pochi minuti da un medico di pronto soccorso.
CHE FINE HAN FATTO LE VITTIME DI TRAINI?
Qualche settimana fa siamo tornati a vedere, dopo tre anni dai fatti, che cosa ne era delle vittime delle pallottole fasciste di Luca Traini. A quanto pare in pochi si erano posti la domanda?
MACERATA. Che fine hanno fatto le vittime di Luca Traini? Non sembra esserci domanda più esotica nella città resa giornalisticamente celebre dalla “tentata strage aggravata da odio razziale” (così la Cassazione che ha confermato 12 anni di carcere) avvenuta il 3 febbraio 2018 per mano di un culturista di ventott’anni, candidato consigliere leghista con un “dente di lupo”, il logo nazista pre-svastica, inciso sulla tempia destra, e una libreria domestica essenzialmente composta dal Mein Kampf. Non lo sa l’ex sindaco («immaginavo che fossero sistemati»). Risultano irrintracciabili per i loro avvocati d’ufficio. Lo ignorano gli sparuti avventori del mercato di piazza Mazzini. «Vittime? Non saprei, ma grazie a Dio sono rimasti solo feriti» dice un commerciante, infilandosi in un labirinto di distinguo che sfocia in un programma di Rete 4 dove avrebbe visto brutte scene di degrado con protagonisti altri immigrati. Tra i pochi ad aver preso sul serio l’interrogativo ci sono gli autori del documentario in lavorazione Fortunatamente non si è fatto male nessuno, citazione carpita a un passante in quei giorni di paura e delirio a Macerata. Perché, se è vero che servono migliaia di morti per far scrivere di Africa, sei neri presi a pistolettate e impunemente ancora vivi equivalgono a nessuno. Anzi, a niente. Non è successo niente.
MANCONI: “MACERATA? UNA CATASTROFE CULTURALE”
All’indomani dei fatti di Macerata avevamo chiesto a Luigi Manconi, senatore in scadenza (non è stato ricandidato e come risarcimento sarà presidente dell’Unar, l’ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali), sociologo con una lunga militanza dalla parte di chi ha meno diritti, dai carcerati agli immigrati, nonché studioso del razzismo. Hombre vertical della cui perspicacia una sensata compagine di sinistra avrebbe fatto meglio a non privarsi:
Com’è possibile che i suoi compagni di partito abbiano aspettato così tanto per dire così poco?
«All’origine c’è una catastrofe culturale. A questo credo fermamente, non al fascismo strisciante perché il numero di razzisti e fascisti, ancorché in crescita, costituisce tuttora una minoranza irrilevante. La catastrofe invece ha una storia lunga 25 anni, da quando l’immigrazione è diventata un fenomeno significativo anche in Italia. Nel ‘90, con Laura Balbo, già scrivevamo degli “imprenditori politici della paura” e dei “razzismi possibili”. Che oggi si sono trasformati in razzismi reali. Già allora sentivamo dire “non sono razzista ma…”, eppure quella frase oggi ha assunto una tonalità ancora più drammatica e sembra corrispondere a una domanda di soccorso: “Aiutatemi a non diventare razzista”».
Termine, peraltro, che lei usa con moderazione: perché?
«Perché il vero problema è la xenofobia, che non è sinonimo di razzismo e che significa esattamente ciò che indica l’etimologia: paura dello straniero. Una pulsione profonda della psiche che accompagna da sempre la storia dell’umanità. Che non è razzismo, anche se può diventarlo, ma non è fatale che così accada. Sta a noi, sta alla politica, evitarlo».
Temo che non ci siate riusciti troppo bene, o sbaglio?
«Non sbaglia, e torniamo alla catastrofe culturale. La sinistra ha risposto con la retorica della solidarietà e l’ideologia del multiculturalismo, con un racconto che ha ignorato la ruvida e dolente realtà delle faticose relazioni tra residenti e immigrati. Di fronte alle sofferenze degli strati più deboli ha saputo offrire solo slogan: fraternità predicata dai privilegiati ai non privilegiati perché accogliessero gli ultimi fra gli ultimi».
TRA LA VIA DOMIZIANA E IL WEST
La sera del 13 luglio 2014, mentre quasi tutti guardano la finale dei mondiali, il trentenne ivoriano Youssuf Baba attraversa il centro di una derelitta frazione tra Mondragone e Castel Volturno con una bombola del gas sulla bicicletta. Pasquale Cipriani, titolare della Custodia, un servizio di guardianìa che vigila per conto dei proprietari su alcune centinaia di villette lasciate vuote o in affitto, è di pattuglia col fratello Cesare. Fermano il ragazzo, gli chiedono dove ha preso la bombola. «Non sono affari vostri». Parte uno schiaffo. Il nero si difende e inizia una colluttazione. Qui le versioni si biforcano. Per i Cipriani arriva una dozzina di africani, circondano la loro macchina, li minacciano. Per Nicolas Gyan, un muratore che passa di lì, ci sono due bianchi che picchiano un fratello con dei bastoni e lui interviene per dividerli. C’è un’indagine sulla dinamica. L’esito, invece, è più chiaro. Cesare, il ventenne figlio di Pasquale e omonimo dello zio, viene avvisato e si precipita con una pistola non registrata, senza porto d’armi, con cui gambizza Youssuf e Nicolas. Decine di africani prendono d’assedio la vicina sede della Custodia. Tirano sassi, danno fuoco alle auto parcheggiate. Le fiamme si alzano verso il primo e il secondo piano dove vivono i familiari dei Cipriani, che rimangono intrappolati per quasi un’ora. L’indomani la via Domiziana viene bloccata: da una parte gli italiani, dall’altra i neri, nel mezzo la polizia, il sindaco e i rappresentanti delle associazioni di immigrati. Il peggio è scongiurato però a tutti torna in mente il settembre 2008, quando i sicari del boss Giuseppe Setola massacrarono sei ghanesi innocenti. Il pezzo (qui in integrale) iniziava così e ne esiste anche una versione webdocumentario:
CASTEL VOLTURNO. Da queste parti manca tutto, tranne l’ospitalità. Così, alla fine di un’intervista tra tante, ti chiedono di restare per pranzo. Dalla strada non asfaltata, piena di buche e circondata da case cadenti da dove escono innumerevoli giovani africani, di questa villa non si intuisce niente. La vista è totalmente ostruita da una recinzione di oltre tre metri, con minacciose lance alle estremità, da caserma più che da abitazione. Un cartello avverte: «Attenti al cane. E al padrone». L’immagine di una pistola sgombra il campo da qualsiasi sospetto di ironia. Chi l’ha appeso mi lascia entrare a patto che non riprenda niente. Men che meno il giardino e la piscina. Sua suocera ha preparato una pasta con salsicce piccanti, pomodoro e funghi. Fuori sono trentacinque gradi. Intorno alla lunga tavola, sei adulti e quattro bambini mangiano girando gli spaghetti in un cucchiaio. Chi non guarda la tv fissa la telecamera a circuito chiuso che punta la strada. La donna mi racconta che la vita a Pescopagano («Pescopa-ghana» l’ha ribattezzata qualcuno) è ormai insopportabile. Che i neri rubano, spacciano, fanno quel che vogliono. E quindi non c’è da meravigliarsi se, com’è successo la settimana prima, qualche bianco esasperato spara. Dice: «Ci hanno abbandonato» e invoca le istituzioni. Il padrone di casa annuisce con la testa. Poi, mentre arriva la caponata, confessa che ha fatto tredici anni in galera perché era «dinto o’ sistema», che è il modo in cui gli addetti ai lavori chiamano la camorra. Solo estorsioni, specifica. Ora vivacchia di lavoretti («Sì e no 500 euro al mese»), quando capita dà una mano ai vigilantes privati che qui gestiscono l’ordine pubblico. E la villa? «È di uno zio di mia moglie, che ce l’ha lasciata». L’ospitalità di queste parti, dove c’è chi butterebbe a mare i neri e scommette su una guerra civile a sfondo razziale, è leggendaria.
CORCOLLE E QUELL’ASSALTO AL BUS MOLTO MA MOLTO SOSPETTO
Qualche mese dopo, a novembre 2014, una cosa molto strana era successa in un remota periferia romana. Una manifestazione con alcuni abitanti aizzati da neofascisti in trasferta (qui l’articolo integrale) contro una presunta sassaiola di immigrati contro un bus. Denunciata da un autista che invece di chiamare la centrale avvisa un altro autista che ha tatuato il duce sul braccio e diventa una specie di capopolo di questa strana rivolta. Che poi farà scuola a Tor Sapienza e in altre periferie. Senza essere mai essere provata in tribunale. Un estratto:
CORCOLLE (Roma). A volte può bastare una bottiglia volante non identificata per mandare in frantumi un piccolo mondo antico. O almeno per dirottare l’attenzione dalla luna dei problemi veri di una borgata disastrata al dito di un’emergenza inesistente ma mediaticamente accattivante. Succede a Corcolle, estrema propaggine di Roma Est. L’unica parte della capitale che pretende un pedaggio autostradale o in alternativa si può raggiungere in un paio d’ore di autobus con lo stesso coefficiente antropologico di un viaggio in Interrail. Cercate su Google e l’oracolo elettronico, giusto sotto Wikipedia, il meteo e il sito del comitato di quartiere, vi rivelerà il motivo della recente notorietà: «Roma, assalti ai bus: a Corcolle è caccia ai neri», recita il titolo di un articolo. Che ha intristito la stragrande maggioranza di cittadini che non ha alcun problema con gli stranieri. E fatto schiumare l’esigua minoranza arrabbiata che, per contestare la maniera in cui è stata dipinta, usa argomenti tipo «Razzista io? Sono loro a essere negri». E tuttavia il cronista venuto a trascorrere quasi una settimana qui a un mese dai fatti che stiamo per ripercorrere non ha vita facile. Perché questo, infinitamente più del presunto scontro di civiltà, sembra l’epicentro di una politica transgender, dove nessuna vecchia etichetta attacca più. Con un presidente di circoscrizione piddino che promette di cacciare tutti i rifugiati. Un ex Forza nuova trasmigrato a Forza italia che firma manifesti anti-invasione con iconografia leghista ma poi definisce «beceri» i loro discorsi. E un aspirante capopolo che da dietro i suoi RayBan neri a goccia giura di essere di sinistra mentre lancia la sua Opa ostile all’appassionato comitato di quartiere assieme a un autista con l’A noi mussoliniano tatuato in latino sull’avambraccio.
DA LEGGERE: PATRIA 2010-2020
Storia recente del Paese, con il suo sublime, il così-così e gli sprofondi di abiezione. Straordinariamente raccontata come tutta la serie Patria (Feltrinelli) di Enrico Deaglio che andrebbe introdotta nelle scuole di ogni ordine e grado. Sotto un estratto su un caso celebre che riguardava immigrati:
Il 24 ottobre una frazione di circa 600 abitanti, Gorino, è sulla bocca di tutti. Ed è strano, perché il paesello è uguale a molti altri in Italia: fa parte del più grande comune di Goro (noto per aver dato i natali a Milva – la pantera di Goro –, in tutto quasi 4000 anime), nel punto dell’Italia in cui il Po sfocia nell’Adriatico, a cavallo tra Veneto ed Emilia-Romagna (ma giuridicamente nella seconda), i cittadini vivono di pesca, di esportazione di vongole, l’ospedale più vicino è a 50 chilometri, così come il primo centro commerciale, la scuola è stata chiusa e la vita si svolge attorno al bar, situato dentro l’ostello Amore-Natura, che d’estate riesce ad accogliere qualche turista. Ma, dicevamo, ora ne parlano tutti, per un motivo semplice e molto preoccupante: circa la metà dei suoi abitanti ha barricato la strada con bancali di legno per impedire l’arrivo di un pullman di immigrati, che dovrebbero essere accolti nell’ostello a secco di visitatori. Dicono che non li vogliono, che lì non c’è niente per loro, figurarsi per altri: tutti ripetono un’espressione che ormai serpeggia ovunque, “non sono razzista, ma”, che di solito continua con un “ho paura”, “da quello che si legge in giro portano guai”, “ci sono tanti posti in cui possono andare, perché proprio qui?”. La temibile ondata di extracomunitari, in effetti, spaventa: a Goro, che di migranti non ne ha nemmeno uno, dovrebbero arrivare ben dodici donne, di cui una incinta, e otto bambini. Saranno costretti a essere dirottati altrove dopo una giornata (e una nottata) convulsa. Il fatto, però, rimane: un paesino è diventato comunità per allontanare venti persone, non le ha volute perché le loro questioni non li riguardano, perché vive come un’ingiustizia gli aiuti che vengono dati ad altri, mentre loro arrancano nei postumi della grande crisi. Ed è il segno che il Paese è ormai arrabbiato e impaurito, insomma non promette niente di buono.
DA VEDERE: GLORIA MUNDI
Duro, durissimo, un Sorry We Missed You a Marsiglia. Con gli attori feticcio di una vita (Ascaride, Darroussin, Meylan) ma con meno speranza del solito. Robert Guédiguian racconta di gente costantemente sull’orlo della catastrofe finanziaria, con quella terribile proprietà moltiplicatrice delle sfighe che affliggono quelli che arrivano a stento a fine mese. La vita com’è, per molti, non come dovrebbe essere.
DA SENTIRE: ACCENTUATE THE POSITIVE
Per non finire su una nota troppo disperante, Accentuate The Positive cantata da Ella Fitzgerald.
Epilogo
«Stati Uniti, Svizzera, Francia, Germania, Svezia, diciamo il mondo avanzato, riconoscono il diritto di esilio e poi magari lo fanno pagare carissimo rendendo la vita impossibile ai rifugiati; noi ufficialmente non garantiamo l'asilo a nessuno, salvo che a quelli dell'est comunista e poi, nel sommerso della pratica poliziesca e burocratica, magari, siamo più permissivi e ospitali. Non ci piace essere cattivi, ci basta essere ipocriti» scriveva Giorgio Bocca su Repubblica il 9 giugno 1988. Un pezzo memorabile che scolpiva il carattere patrio e proseguiva così: «Il mondo dei poveri è in cammino verso le terre dei ricchi. Qualcuno lo chiama il Sesto continente ed è un continente in moto continuo, incrociato, eterogeneo, incontrollabile perché nessuna forza al mondo sembra capace di fermare questa macchina della vita». Sono passati più di vent'anni ma, aggiornati i numeri, i ragionamenti sembrano fatti ieri. Ci piace tanto importare hashtag e mode social: perché non #levitedeinericontano?