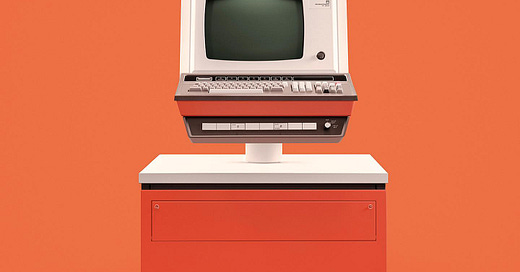#105 Estetica del computer
Nel momento in cui hanno smesso di essere (solo) strumenti di calcolo per diventare strumenti di comunicazione hanno sentito il bisogno di diventare belli; che fatica disabbonarsi da Prime
ARTICOLI. LIBRI. VIDEO. PODCAST. LIVE. BIO.
INFORMATICA, UNA STORIA PER IMMAGINI
Dal’ultimo Venerdì.
Che cos’è un computer?» è la domanda centrale di un librone di settecento pagine della Taschen. E, lungi dall’essere l’interrogativo amatoriale di una casa editrice specializzata in arte, è una domanda filosofica. Che mira a cogliere l’idea platonica di computer, la computerità, per così dire. Posseduta tanto dai mainframe che occupavano intere stanze quanto dagli smartphone odierni che rispetto ai loro antenati hanno misure mini ma prestazioni maxi, espresse in una potenza di calcolo infinitamente superiore. E qui ci avviciniamo al nocciolo incandescente della faccenda. Recita la Treccani: «calcolatore elettronico, cioè una macchina che è in grado di accettare e immagazzinare al suo interno una grande mole di informazioni in una forma determinata, di elaborarle e di fornire i risultati dell’elaborazione sotto forma di dati digitali». Che è, ovviamente vero, ma anche parzialmente falso. Nel senso che col tempo i computer si sono trasformati sempre più da strumenti di calcolo a strumenti di comunicazione. Nicholas Negroponte, allora a capo del Media Lab del Mit, fu tra quelli che colsero la metamorfosi prima e meglio. Correva l’anno 1994 e il suo libro seminale Essere digitali conteneva l’intuizione fondamentale: «L’informatica non si occupa più di computer ma della vita. I bit, il dna dell’informazione, stanno rapidamente rimpiazzando gli atomi come materia prima di base dell’interazione umana». In questo passaggio dalla matematica alle lettere, nel trasloco dai laboratori agli uffici e soprattutto alle case, e poi dalle scrivanie alle tasche e quindi ai polsi o negli occhiali, c’era incisa una necessità ineludibile: diventare belli.
CASTELLO O PALAZZONE?
Il volume di Jens Müller con Julius Wiedemann si occupa, da vocazione editoriale, di questa transizione estetica. Decisiva perché chi l’ha capita ha prosperato, chi l’ha sottovalutata è deperito. Nell’81 i primi pc dell’Ibm, per dire, erano beige. E dire che l’interfaccia grafica di Windows che montavano non fosse carina significa candidarsi al Premio eufemismo 2023. Steve Jobs, appassionato di calligrafia e Bauhaus, non se ne faceva una ragione: «Il solo problema con Microsoft è che non hanno gusto, proprio per niente, zero» sentenziava in una celebre intervista del 1995 e ciò comporta che i loro siano «prodotti di terza categoria». Brutti, troppo brutti. Si ossessionava su come, potendo scegliere se vivere in un castello (i Macintosh, ovviamente) o in un palazzone da realismo sovietico (tutto il mondo non Apple), gli utenti preferisserola seconda opzione. Il che lo rattristava profondamente perché uno dei migliori modi per «far crescere la specie è prendere il meglio e mostrarlo a tutti per far apprezzare i dettagli che rendono alcune cose grandi e migliori di altre. Microsoft invece è come McDonald’s». Anni dopo il suo amico nonché Ceo di Disney Bob Iger racconterà al Venerdì del godimento fisico che Jobs provava nel sentire il clic perfetto che la calamita di un loro caricatore faceva staccandosi dalla presa del portatile.
ARCHEO(TECNO)LOGIA
Nonostante il parossistico upgrade dell’omerico kalos kai agatos, «bello quindi anche buono», la guerra tra Atene (Apple) e Sparta (Microsoft) allora l’aveva stravinta la seconda piazzando il suo sistema operativo su quasi nove computer su dieci. D’altronde i computer abitavano principalmente in ufficio. Qualche avanguardista li teneva già in casa, ma relegati negli studi. Il campo di battaglia era in ogni caso indoor. Quando dalle stanzette minori passano in salotto e ancor di più quando dal chiuso cominciano a uscire all’aperto le proporzioni cambiano. Con il salto quantico del 2007, anno del primo iPhone, in cui un computer a tutti gli effetti trasmigra nelle nostre tasche. A quel punto le aspettative estetiche si equiparano a quelle dei vestiti, delle scarpe, degli orologi: vogliamo il calcolo e le rose! E oggi Apple, la prima azienda al mondo ad aver inaugurato il club delle one trillion dollar companies (aziende da mille miliardi di dollari di capitalizzazione che a un certo punto diventeranno addirittura tremila, ovvero quasi due volte il Pil italiano), oggi dicevamo il suo sistema operativo fa funzionare un computer su tre mentre quello di Microsoft è sceso a uno su cinque. La differenza, oltre alla facilità d’uso, l’ha fatta la bellezza.
Lo stesso fattore che ha condannato i Google Glass, computer sotto forma di occhiali sgraziati e che forse (un grosso forse) risparmierà la loro evoluzione firmata Meta e Luxottica che, non a caso, per la medesima funzione ha scelto la forma degli iconici Wayfarer Ray-Ban. The Computer è anche una lunga cavalcata nei sentieri della memoria di chi, come il cronista, aveva 14 anni quando uscì il Sinclair ZX SPectrum e scialacquava paghette a migliorare la tecnica (joystick, il “bastoncino della gioia”) tra Space Invaders e Pacman. Mi candido sin d’ora, se qualcuno volesse mettere in piedi un museo sul retrocomputing, a donare la mia collezione di reperti: un’agendina elettronica Casio da 256kb che all’epoca era il massimo e adesso non è neppure considerabile memoria. Un vero e proprio computerino Psion, con tanto di tastiera fisica, che stava nella tasca di una giacca. Un Sony Clié, tra i primi palmari su cui si scriveva stilizzando le lettere con un pennino in plastica. Giusto per citare le prime cose, alcune reperibili nel libro e altre così da nerd da aver saltato la selezione.
TORNERANNO I COMPUTER BRUTTI?
Resta intatta la domanda iniziale: che cos’è un computer? Il libro ne squaderna la filogenesi, dalle profezie ottocentesche di Charles Babbage e Ada Lovelace ai server di ChatGPT. E ci fa capire, a forza di immagini, che nel perimetro rientrano sia i calcolatori di acciaio e valvole che negli anni 30 cercavano di craccare il codice dei nazisti che l’impalpabile Alexa con cui amabilmente discutiamo.
Se c’è da dirla tutta, il pendolo che ha impresso la svolta dal calcolo alla comunicazione oggi sembra cambiare di nuovo direzione. Il cloud che fa funzionare ogni nostra infrastruttura è composto di server, computer impilati uno sull’altro, che solo i tecnici vedono. Anche i minatori di Bitcoin usavano macchine potentissime ma con la grazia tipica di qualche fabbrica della Cina interna, tutte ventole e plastica.
Per non dire dell’intelligenza artificiale che ha bisogno di una potenza di calcolo spaventosa ma esteticamente senza fronzoli. Torneranno i computer brutti? Intanto rifatevi gli occhi con quelli belli che ci hanno accompagnato sin qui.
LA FATICA OMERICA DI DISISCRIVERSI DA PRIME
L’ultima Galapagos:
I manager, con umorismo nero, l'avevano ribattezzata l'"Iliade". Riferendosi alla difficoltà epica che gli abbonati Amazon Prime dovevano affrontare per disabbonarsi. Per quanto era facile (2 clic) sottoscrivere l'opzione per poter usufruire delle consegne gratuite e tanti altri servizi, altrettanto difficile era cambiare idea, dal momento che bisognava superare 4 pagine, 6 clic e scegliere tra 15 diverse opzioni. Non solo: tutta l'architettura del sito era pensata, sfruttando quelli che gli specialisti chiamano dark patterns, ovvero modalità implicite per spingere un utente a fare una cosa anziché un'altra, per favorire la sottoscrizione e scoraggiare fortemente l'addio all'accordo forfettario con l'azienda di commercio elettronico. E così facendo avrebbe frodato milioni di clienti, sostiene l'accusa di Lina Khan, la zarina antitrust della Federal trade commission.
Lina Khan, la donna che fa paura a Big Tech
Il motivo per cui era così importante tenere legati i clienti è presto detto: in media un abbonato Prime spende 1.400 dollari all'anno contro i 600 di un non Prime. C'è quindi da fare di tutto per tenerli legati. «Se cancellare Prime era un'Iliade» ha commentato il fondatore dell'Amazon Labor Union Chris Smalls , «formare un sindacato dentro quell'azienda è un'Odissea: un lungo, arduo viaggio che dobbiamo assolutamente portare a termine». Per poi continuare: «Se date 14,99 dollari al mese per Prime», soldi che servono a finanziare anche i 14 milioni che solo l'anno scorso l'azienda ha speso per contrastare la sindacalizzazione dei suoi lavoratori, «allora potete anche stanziare 5 dollari o più al mese per controbilanciare quella somma». Non fa una piega. Prima che tanti ex-Prime, sentendosi traditi, non comincino a recitare la loro parafrasi del più celebre incipit: «Cantami, o Diva, del pelide abbonato, l'ira funesta»…